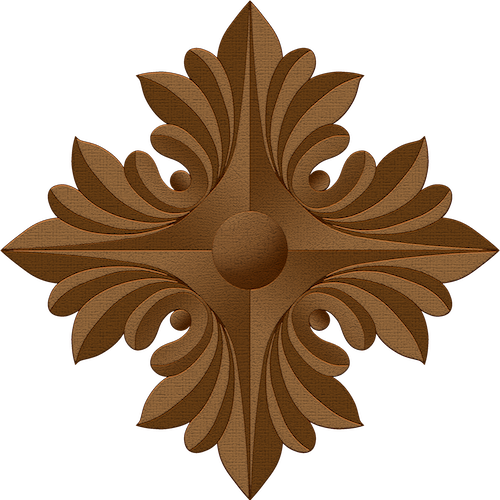di Gianfranco Mingozzi
di Gianfranco Mingozzi
Con quale immagine cominciare? L’acciottolato grigio di una strada ferrarese o i mattoni rossi di un portico bolognese, un’alta torre medioevale o la distesa calma fluviale di un delta senza tempo? Il paesaggio delle campagne e delle città dell’Emilia – io mezzo ferrarese e mezzo bolognese – è entrato molte volte nei miei film, da protagonista, o come sfondo ma sempre importante, necessario, seguendo il mio itinerario di regista, dal documentario al lungometraggio a soggetto.
E’ stata proprio una via di Ferrara la protagonista del mio primo lavoro di autore cinematografico: dieci minuti di immagini di Corso Ercole, in una lunga carrellata dal Castello degli Estensi ai verdi bastioni che si affacciano sui campi in vista del Po. Un itinerario della memoria lungo l’antica “via dei Piopponi”, seguendo i passi di un bambino – io stesso – che molti anni prima ero venuto dalla provincia a scoprire i muri, le statue, i parchi, i palazzi di una città vicina e sognata. e attraverso l’ottica infantile, il Castello diventava un baluardo di guerra; le statue personaggi con cui giocare; i giardini, visti attraverso alte cancellate, i luoghi magici di fiaba; le punte aguzze di pietra del Palazzo dei Diamanti, armi con cui difendersi da un nemico immaginario i pioppi e le piccole case all’estremità della strada avvolta nella nebbia, luoghi famigliari a cui tornare dopo un viaggio avventuroso …
L’avventura del mio lavoro, che per anni mi aveva portato – per ragioni esterne e per cause più intime (il bisogno di dimenticare traumi adolescenziali e dolori giovanili, l’incapacità momentanea di travasarli nelle mie storie) – lungo le strade di un’altra Italia e del mondo, mi riconduceva poi improvvisamente ad un luogo deputato della mia vita, la città dove avevo condotto i miei studi e da cui mi ero strappato coscientemente, il bisogno di ritrovare i miei umori e l’origine di quello che ero diventato, si snodava così attraverso le immagini di un libero realvissuto, fantasia, ma non troppo, per violino: Bologna, parallelo alla necessità di raccontare la nascita, lo sviluppo, la storia di una città già amata, inutilmente abbandonata e volutamente dimenticata. il paesaggio urbano – tra documento e finzione – diventava in tal modo anche la mia storia, gli itinerari del passato risuonavano così anche dei miei passi, il suo sviluppo proiettava nel futuro anche il mio sguardo. E le torri del Mille erano le stesse dei miei primi amori, i portici di via Zamboni quelli che avevano visto le mie paure di studente; i personaggi della famiglia Bentivoglio (interpretati tutti in maniera proteiforme da una cangiante Piera Degli Esposti) vecchi amici di lotte e di follie; l’adorato Teatro Comunale del Bibbiena era il medesimo sfondo che aveva assistito alla nascita del fanatismo cittadino per Wagner e alla mia passione per l’Opera; versi e musiche del cantastorie Giulio Cesare Croce (un sorprendente Francesco Guccini) e riverberavano nelle piazze le sue e le mie ironie, poesie, scontentezze. Insomma, paesaggio di una città come retroterra non naturalistico, colto dalle sue origini non in maniera nostalgica ma critica, lucida, anche se personale, storicizzato nella sua gente e nelle sue innate tendenze costruttive e quindi nelle sue spinte vitali verso il futuro: una città da amare (di nuovo).
Bologna era lo sfondo e la cornice anche del mio successivo film Gli ultimi tre giorni che potrei considerare la prima parte di una trilogia sull’adolescenza “ferita” durante il periodo fascista. Il film, raccontava mediante l’interpretazione di un episodio storico – l’attentato a Mussolini compiuto appunto a Bologna nel ’26 e attribuito al quindicenne Anteo Zamboni – l’ambiguità e la violenza di un fascismo che stava per vincere definitivamente. E l’immagine della città attraverso il mio obbiettivo, cercava di restituire quell’atmosfera, quel clima, quell’epoca. Il colore era rosso scuro; la luce era volutamente contrastata (dal nero dei cortili alla luminosità eccessiva di una piazza); le linee portanti dell’inquadratura (le torri, le strade, certi interni) erano verticali come un grido; le colonne dei portici, colte in veloce carrellata, erano come la premonizione dei colpi di pugnale che avrebbero straziato il giovane corpo di Anteo. Il paesaggio urbano, quindi, come commento visivo ad una interpretazione di una storia, di una realtà. La stessa ricerca che ho cercato di fare anche nella seconda parte della trilogia sull’adolescenza, il film La vela incantata: non più come una città, ma attraverso le immagini della pianura, della Bassa Padana tra Ferrara e il delta. era il paesaggio della mia infanzia, tagliato da canali con alti argini, da pioppeti e da campi di canapa, da stagni e da basse cascine. (E che fatica ritrovarlo intatto, che ricerche, che adattamenti, in un ambiente stravolto da una vita profondamente mutata!). era il paesaggio adatto a raccontare una storia, in parte autobiografica, dove le violenze – di un fascismo ormai dominante e di una borghesia che contrastava ogni ribellione ed ogni diversità – erano sotterranee, silenziose.
E così la chiave visiva era orizzontale, distesa. E l’immagine dominante era quella dell’acqua, acqua immobile delle anse del grande fiume, dei canali; e il colore era azzurro degli orizzonti bassi che si stemperava nel bianco del telone, lo schermo dei fratelli ambulanti, la “vela” magica su cui si accendevano ogni sera nelle aie dei contadini nelle piccole piazze dei borghi, le tavole del cinema. Ma dallo specchio tranquillo del canale sorgeva improvviso, appeso ad una fune il corpo senza vita del confinato politico. Sul candido schermo si accendevano, stridenti, i contorni di una vita povera e quotidiana: sull’acqua quasi immobile dell’immenso delta una barca portava, nel finale, un ragazzo ormai consapevole della realtà. E il paesaggio che (mi) sembrava – nella vita e nel film – da guardare con dolcezza, con lirismo (sfondo e cornice solo esterna) si ribaltava così in una trama visiva da interpretare, da leggere in controluce, da vivere come momento profondo, interiore della coscienza emiliana. dopo la città – Bologna – de Gli ultimi tre giorni e la pianura – la Bassa Padana – de La vela incantata, il paesaggio della terza parte – Le lunghe ombre – di questa ideale trilogia sull’adolescenza è la montagna (l’Appennino Modenese).
Paesaggio fortunosamente intatto, paesaggio di boschi, casali, aie, ville sperdute, cimiterini di paese, baracche partigiane. Paesaggio capace di accogliere senza ostacoli, quasi maternamente – e tragicamente – la vicenda di una diva del regime e di due amici adolescenti che diventano uomini o soccombono attraverso la terribile esperienza della guerra e della violenza; vicenda ambientata nei fuggiaschi mesi dell’inverno ’44. Questo paesaggio ha tuttavia una valenza diversa da quella dei film precedenti. Una valenza corale di controcanto, da cui sboccia e si dirama il composito “paesaggio” interiore che questa volta è rappresentato dai gesti, dall’intreccio delle azioni, dei sentimenti, che il guado del passato mi riporta: “i ricordi, queste ombre troppo lunghe del nostro breve corpo…” come dice il verso di Cardarelli che ha ispirato il titolo del film. Paesaggio interiore umano, dunque, ma perpetuamente presenziato e atteso dal paesaggio reale, i boschi, gli alti, enigmatici, scuri boschi da cui, in crescendo, sarà accerchiato, avviluppato, serrato, fissato in tre figure dominanti: la morte, la pietas, la follia di una fuga impossibile.