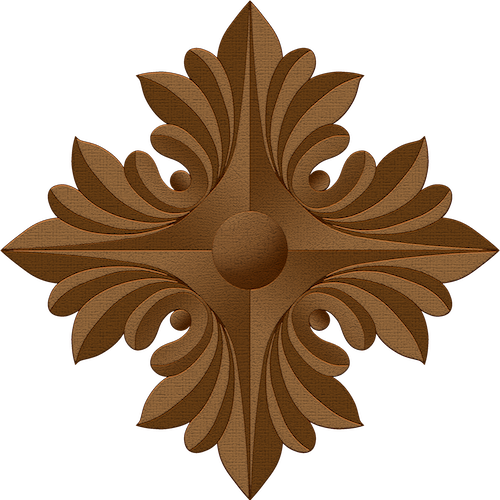di Pasquale Grella
di Pasquale Grella
La storia del brigantaggio, o malandrinaggio, nella campagna romana – in particolar modo nell’area compresa fra la Via Latina e la Via Ostiense – ha radici antichissime risalenti agli antichi romani che dovettero istituire corpi di gendarmeria a protezione di viandanti e contadini, abitanti nelle innumerevoli residenze presenti nella zona. Già Cicerone nella sua orazione Pro Milone ne accennò, definendo la zona Locus Latronum occultator et receptor .
La Roma che in questa occasione andiamo a leggere è una città che scopre lasua campagna, o parte di essa, che usa ed abusa delle sue ricchezze, ma che fa parte della storia di noi tutti.
Dopo i fasti dell’Impero ed il successivo buio del Medioevo, Roma rinasce tra il XIII ed il XIV secolo: in questi anni la sua popolazione è ridotta a poco più di 17.000 anime; la città è priva di acqua potabile, tutte le strutture urbane sono in condizioni fatiscenti, branchi di lupi stazionano addirittura all’interno della città (P.Tomei L’Architettura a Roma nel ‘400).
Dalle memorie di Cola di Rienzo si viene a sapere che i pellegrini, in arrivo nella Città Eterna per pregare per la salvezza delle proprie anime, vengono abitualmente assaliti ed anche uccisi tra l’indifferenza della popolazione residente. È il ritratto di una città in completa decadenza, dove perfino alcuni prelati gestiscono discutibilmente le loro parrocchie. Difficile è la vita per la comunità ebraica, chiusa nel suo ghetto e ridotta in vero e proprio stato di sottomissione dai più squallidi personaggi di rione, che inventeranno perfino il “gioco della botte” per offendere ulteriormente il popolo giudaico: gioco consistente nel rinchiudere il malcapitato proprio in una botte e, dopo averlo portato su un rialzo stradale, farlo rotolare fino ad indirizzare la stessa contro un eventuale ostacolo.
Per la sua rinascita la città riutilizza se stessa, recuperando dall’antica Urbe e dall’Agro Romano, in genere, il materiale necessario. Nasce la figura del “cavatore”, colui che cava e recupera pietre e marmo da vecchie costruzioni, siano esse residenze dell’antica Roma che umili abitazioni abbandonate per svariati motivi. Papa Martino V definirà i cavatori una vera e propria categoria professionale.
A causa di questo processo di “riutilizzazione”, la Via Appia Antica e la Via Latina subiscono danni gravissimi, anche se pur sempre limitati rispetto a quel che devono tollerare tutte le altre vie imperiali romane: l’Appia Antica verrà addirittura soprannominata “la cava di marmo”…la gran quantità di statue antiche in procinto di essere cotte per ricavarne materiale edile, rinvenute nei luoghi di scavo nei pressi della Villa dei Quintili, darà nome ad un’intera zona urbana, lo Statuario.
Nel 1462, con la Bolla Papale del 28 aprile, il Cardinale E.S.Piccolomini tenta di mettere fine alla devastazione in atto. Ma è solo all’affermazione della cultura umanista che si deve, in realtà, la salvezza di gran parte del nostro patrimonio archeologico. Leon Battista Alberti, architetto umanista, ricorda: “Restavanci gli esempi delle cose antiche ancora intatte, dalle quali come da perfetti maestri si potevano imparare molte cose, ma io le vedevo non senza le mie lacrime consumarsi di giorno in giorno” (lettera a G.de’Medici, marzo 1443).
L’Agro Romano, dopo il saccheggio, è abbandonato totalmente a se stesso: poche le attività agricole svolte, ancor meno numerosi gli interventi di manutenzione dei fossi e dei percorsi d’acqua, nessuna traccia di manutenzione del sistema viario. L’unico legame produttivo che lega la città alla campagna è l’estrazione di materiale dalle cave di pozzolana, di tufo, di selce (materiali estremamente ricchi e facili da trasportare) presenti lungo gli assi viari del Tuscolano, Casilino, Appio e Ardeatino. La situazione sanitaria è al limite della sopravvivenza; per combattere la famigerata malaria si interviene con pochi mezzi e tanta confusione: noto, a tal proposito, l’intervento nel 1802 di M.Leopardi a Casetta Mattei, che non riuscirà a portare a termine un’ipotesi di bonifica, ma registrerà la morte di oltre 80 contadini.
A questi ultimi, sopportati con fastidio dalla popolazione cittadina, soggetti ad ogni tipo di angheria, ridotti a merce dai proprietari o affittuari delle terre, viene impedito di costruirsi una propria casa, concedendo solo l’uso della capanna come dimora, facile da smontare al termine del contratto stagionale. L’analfabetismo e l’arretratezza culturale degli stessi creano uno spartiacque a ben vedere insormontabile; antiche pratiche di sortilegio esasperano odi originari…ciarlatani e comari portano alla morte sociale e fisica intere fasce di popolazione rurale. Inoltre, l’istituzione delle scuole di campagna non avverrà senza grossi traumi sociali.
È quindi logico pensare che, in questa situazione di degrado, la criminalità più o meno organizzata in bande, trova terreno fertile. E neppure la “Roma Capitale d’Italia” riesce a divenire il simbolo del riscatto, anzi, viene declassata dalla nomenclatura intellettuale europea come la “Capitale di un piccolo regno di secondo ordine”, come ebbe a dire Fêdor Dostojevsky.
Solo nel nostro secolo l’Agro Romano torna a conoscere momenti di interesse culturale: diviene teatro di tutta l’evoluzione della produzione cinematografica italiana degli anni ’40-’60, che in questa zona ambienta numerosissimi film, fino a raggiungere momenti di elevata poeticità con le riprese de La Ricotta di P.P.Pasolini, girato nella Valle della Caffarella. Noti i soggiorni di Moravia, Visconti, Ravera, Morante, Rossellini ed altri in questo territorio. Perfino C.E.Gadda ambienta il suo pasticciaccio brutto di via Merulana negli attuali confini del parco dell’Appia Antica.
IL SACCHEGGIO DELLA MEMORIA
Il richiamo della Roma antica, che portò fin qui schiere di “viaggiatori” dalla fine del 1600 a tutto il ’900, contribuì all’incremento del saccheggio di tombe e monumenti antichi a scopo di lucro.
Alla richiesta sempre più insistente dei turisti, a caccia di “souvenir” da riportare in patria dopo un viaggio nella Città Eterna, una fascia di romani dell’epoca risponde adeguandosi a tale esigenza: intraprende così un’attività lucrosa e nient’affatto faticosa. In tal senso l’Agro Romano ed, in particolare, l’area dell’Appia Antica, si rivelano come autentiche miniere d’oro. La zona fu posta sotto il totale controllo di briganti e teppisti, “facili de cortello”, gente senza scrupoli, pronti all’azione criminale nei confronti di viandanti, pellegrini e commercianti. Il quartier generale di questi personaggi diviene l’intera area compresa fra l’Osteria dei Cessati Spiriti alla Caffarella e le grotte di tufo fra la Tuscolana e la Casilina (da Porta Furba alla deviazione del Fosso della Marrana – attuale Via di Torpignattara).
A partire dal 1814 si consegnarono alle autorità pontificie schiere di malviventi e delinquenti comuni che giustificavano con la lotta antifrancese ed antigiacobina le proprie malefatte, spesso motivate in realtà da vendette di squisito sapore personale.
Ed è proprio nei luoghi prima citati, nelle capanne e nelle osterie, che si raccolgono informazioni sulle “collinette” sotto le quali può celarsi una tomba antica, sui frammenti di marmi sparsi nei terreni, sui pozzi d’acqua scavati nelle doline tufacee dove eventualmente nascondere il “tesoro”. Si svolgono ricerche anche sugli oggetti già in possesso degli abitanti dei luoghi che, opportunamente ritoccati, verranno venduti o donati. Infatti, molto spesso, avvenimenti come la caccia alla volpe o le corse dei cavalli alle Capannelle richiamano gruppi di intellettuali o signorotti disposti a pagare qualsiasi cifra per un oggetto antico da sistemare nelle loro residenze o da regalare alla “signora” o “soubrette” del momento. Intere aree vengono saccheggiate, quali lo Statuario, il Campo Barbarico, le Tombe Latine, la Via Latina ed in particolar modo l’Osteria del Curato, dove viene portato alla luce, dopo uno scavo, un intero villaggio antico di cui non si avrà più alcuna traccia, tranne che per un piccolo gioiello esposto al museo di Palazzo Massimo. Ma fu durante il pontificato di Pio IX che il mercato dell’antichità prende maggior consistenza in Roma. Oggetti del commercio sono, essenzialmente, i ritrovamenti del sottosuolo, suddivisi per categorie ed interessi. Marmi e materiale edile vengono indirizzati direttamente alle fornaci; oro e metalli preziosi nei palazzi della nobiltà, il rimanente a Piazza Montanara (ora demolita), dove il sabato sera si svolge una vera e propria fiera dell’antiquariato, luogo d’incontro dei pastori dell’Agro Romano che qui si danno appuntamento.
Fin dai tempi antichi l’arte dei “tombaroli” era fortemente perseguitata dal potere, come dimostrato da varie leggi e decreti : il Comes ninentium rerum di Augusto, la legge di Leone e Mairano del 458 d.C., le disposizioni di Re Teodorico, la Bolla di Martino V del 1425 (limitatamente alle aree all’interno delle mura) e quella di Pio II del 1462, le proibizioni Aldobrandini del 1624, l’editto Doria del 1802 e quello di Pacca del 1820. Tutte disposizioni che non furono, però, quasi mai applicate e che, quindi, non riuscirono mai efficacemente a contrastare questa attività. Nel periodo settecentesco è un portiere di Palazzo Massimo a San Giovanni in Laterano, amico dei pastori della Valle della Caffarella, a dare il via al mercato dello “antiquariato” romano, seguito in tempi brevi da un certo “Checco”, abitante in Piazza Barberini. Il culmine degli scavi archeologici ai fini di studio, ma in realtà di lucro, si raggiunge con il Conte polacco M.Tyskiewcz e con L.Fortunati i quali, uno sull’Appia Antica e l’altro sulla Via Latina, riducono le residenze antico romane a vere e proprie “scatole vuote”. Il Fortunati solleverà addirittura l’indignazione del papa Pio IX che, a causa dei danni apportati al patrimonio archeologico, lo caccia dalla città nel 1858. Di non poca entità, inoltre, fu il danno apportato al patrimonio archeologico negli anni successivi, quando divenne moda avere il reperto in casa come elemento decorativo….ancor oggi fra i reati di maggior peso rimane il trafugamento dell’opera d’arte, ma ci si addentra in tal caso in un altro mondo del delinquere, rischiando di uscire fuori dallo studio proposto.
ALLE ORIGINI DEL BRIGANTAGGIO OTTOCENTESCO
Grave senza dubbio fu la diffusione della delinquenza organizzata e, in alcuni momenti, protetta dalle autorità, anche religiose, a causa del sorgente pensiero giacobino, che registrò nella campagna romana una repressione fortissima e uno storico odio nei confronti delle popolazioni campagnole, che furono per molto tempo identificate come classe asservita alla politica papalina.
La storia del brigantaggio è liquidata, in genere, con brevi accenni, ma fu un fenomeno assai complesso e doloroso, che tenne impegnato il giovane Regno in una lotta sanguinosa, ingrata e costosa che interessò anche tutto il Lazio.
Alcuni errori di carattere più propriamente politico crearono una campagna ostile al clero, che vedeva nell’applicazione della nuova legislazione ecclesiale sabauda (soppressione dei privilegi ecclesiali) una vera e propria rappresaglia nei confronti di quella parte della Chiesa di Roma che si era schierata con i regnanti anti-unitari. Ma procediamo con ordine.
Nel 1798 i francesi occuparono l’Italia pontificia e borbonica. Nel contempo, Re Ferdinando IV (1751-1825) di Borbone, rifugiandosi a Palermo, rivolse alle popolazioni l’appello di armarsi e opporsi al nemico. Sempre nello stesso anno, tre giorni dopo la proclamazione della Repubblica romana, si procedette alla proclamazione anche della Repubblica di Velletri. Ma l’opposizione papalina riuscì a far scoppiare un tumulto nella cittadina castellana, richiamando in loco le truppe napoleoniche in stanza a Castel Gandolfo. Era il 27 febbraio 1798 quando le milizie di Murat entrarono in città, ponendo fine alla rivolta, con l’intento – poi rientrato – di distruggere totalmente la cittadina: ma, in tutta l’operazione, si registrò solamente l’abbattimento della statua colossale di Urbano VIII del Bernini.
Il governo repubblicano durò fino al 21 luglio 1799 ma, già a partire dalla primavera dello stesso anno, le sorti dei francesi iniziarono a declinare in tutta Italia; a Velletri avevano fatto apparizione anche le bande comandate da Michele Pezza, il leggendario “Fra Diavolo”, che si spinse fin alle porte di Roma divenendone signore e padrone per tutto il 1799. Le bande dei briganti spadroneggiarono indisturbate fino al 1809 quando le truppe napoleoniche ripresero il controllo su tutta la Campagna Romana; controllo esteso anche nell’area dei Castelli Romani, ad esempio a Nemi così come scrive T.Ashby in La campagna romana nell’età classica: “…dietro la strada medioevale postale (tracciata probabilmente su una strada antica) che era in uso fino ai tempi di Pio VI e attraversava il margine esterno del cratere con una ripida salita per la Macchia della Faiola e con una discesa, fino a Velletri. Una casa sulla strada reca ancora il nome di Casale dei Corsi, dalla polizia corsa che era responsabile della sicurezza della strada; e una collina poco distante reca il macabro nome di Monte degli Impiccati, con allusione senza dubbio all’esecuzione di briganti…”.
In quegli anni diventarono “Briganti” anche giovani contadini e pastori che niente volevano sapere della costrizione militare; questa renitenza si ammanterà, presto, di motivazioni politiche e di principio.
Molte furono le rappresentazioni grafiche riguardanti il trasporto di presunti malviventi attraverso la Via Appia Antica, tutti scortati dalla gendarmeria francese, condotti su carri destinati alle patrie galere.
Nel 1811 si fanno ancora insistenti le indicazioni per sopralluoghi continui in località Osteria delle Frattocchie, dove si ripetono azioni di aggressione nei confronti dei viandanti. Nacque allora anche il sospetto di un’unione criminale fra il brigantaggio romano e quello calabrese, a causa dell’arrivo di tale popolazione nell’area dei colli albani, come riportato in numerose segnalazioni di prefettura.
A Velletri, il 29 ottobre dello stesso anno, avvenne la fucilazione di tre individui condannati dalla commissione militare; numerosi i “delinquenti” sottoposti a regime carcerario domiciliati in Roma, Sora, Genova; nel 1817 un certo Ambrosetti di Anagni fu arrestato nei pressi di San Giovanni e fucilato in P.zza del Popolo; le lettere dei provvedimenti e delle condanne sono per la maggior parte scritte in francese ad ulteriore dimostrazione del distacco, anche sociale, fra i francesi e i cittadini locali.
Ma a detta di alcuni autori, come Massimo d’Azeglio, conoscitore della realtà di Roma e del suo Agro, i Briganti nell’area dell’Appia Antica risultavano essere più una leggenda che una realtà, un’attrattiva per turisti in cerca di avventura. In verità, numerosi furono i Briganti assoldati, apertamente in pubblico in piazza Farnese, dal papato per contrastare altri Briganti ingaggiati come guardie del corpo di nobili e notabili; atto questo della curia romana che fu riportato anche dalla stampa straniera, la quale non mancò di scatenare vere e proprie campagne anti-clericali. Gli arruolati venivano avviati a piccoli gruppi alla frontiera, specialmente ai conventi di Scifelli, Trisulti e Casamari, nei quali erano state precedentemente concentrate armi e munizioni. A nulla valsero le postazioni dei carabinieri di campagna dislocati in tutta l’area dell’Agro: la molla essenziale e principale di qualsiasi azione contro il brigantaggio mancava, ossia, non c’era un corpo di polizia.
Nel 1823 la situazione sembrava esser sfuggita di mano a tutte le autorità competenti; pertanto dovette intervenire direttamente il Papa che diede ordine di deportare all’interno delle Terme di Diocleziano intere comunità accusate di collusione con i briganti. Fu ideato a tal proposito il cosiddetto “Bagno Penale” di Roma, dove hanno subito una carcerazione coatta centinaia di donne, anziani e bambini.
Molte le antiche “ruine” che per l’occasione furono trasformate in abitazione da famiglie scampate alla condanna e costrette a fuggire: il loro numero fu talmente alto da trasformare la situazione in un vero e proprio fenomeno sociale, riportato, purtroppo, in quadri dipinti da autori stranieri che non costituirono, certamente, una bella pubblicistica per la città.
Nel 1826 si moltiplicano le iniziative della Curia di Velletri al fine di mobilitare la popolazione contro il fenomeno della delinquenza organizzata; ad esse seguirono molte altre proposte, sempre su iniziativa della Chiesa, che cercheranno di frenare la solidarietà tra malviventi. Ma il fenomeno, pur attenuandosi, non viene debellato. Solo nella seconda metà dell’Ottocento avviene la vera svolta nelle attività di contrasto alle azioni brigantesche: i comitati borbonici impressero l’avvio, la direzione, la condotta ed il sostentamento alla rivolta nell’estate del 1861. Le condizioni di vita sono drammatiche in tutto l’Agro Romano, un bambino su tre è illegittimo, uno su quattro muore entro il primo anno di vita, uno su tre muore entro i primi quattro anni di vita…la mortalità è ovunque molto alta. Molti degli stranieri presenti in Italia in quel momento (Raphael Tristany Josè Borges, Edwin Kalherenth, Carlo Mayer, Alfredo de Trazegnies, Luvarà De Riviere, il generale Soyon, il conte de Criste, ecc.), sensibili alla causa del legittimismo, si unirono ai rivoltosi. Oltre a Roma i comitati borbonici si insediarono anche nell’area dei castelli Romani, in particolar modo a Velletri. E’ a Roma, comunque, che, nel periodo compreso fra il 1860-63, fecero capo tutti coloro che rimasero ligi alla restaurazione, fautori della guerriglia contro le truppe sabaudo-garibaldine e le strutture del nuovo stato unitario, forti della presenza di numerosi graduati militari precedentemente al servizio delle corone di mezza Europa. La città è l’officina massima del brigantaggio, sia moralmente che materialmente: moralmente perché il banditismo presente nelle provincie napoletane ne trae incoraggiamento continuo ed efficace; materialmente, perché Roma così diventa il quartier generale del brigantaggio di importazione. Si incontrano qui, infatti, personaggi ambigui, saliti alla cronaca per l’adesione ai comitati Borbonici, fautori di guerriglia nel sud pontino e reclutati per politica anti-piemontese, protetti nelle loro azioni dai rampolli di numerose famiglie nobili romani, fra cui gli Sciarra e i Barberini, che si distingueranno per il reclutamento di briganti e apriranno le loro sedi per incontri e feste, al fine di raccogliere denaro per la causa borbonica prima, filo vaticana poi. Al fine di evitare l’assoldamento dei briganti dalle nobili famiglie romane, nel 1861 fu chiamato il commissario di polizia borbonico Sezilli, che risiedeva in Palazzo Farnese.
E come afferma il Massari nella sua relazione parlamentare sul fenomeno del banditismo, i difensori dei Borboni dapprima fecero “coprire di obbrobrio la propria bandiera, non seppero difendere né i loro principi, né il loro re, non seppero arrendersi con dignità né cadere con gloria, si “ripresero la rivincita”, se non quella di collegarsi con gli assassini, di aiutarli con la direzione, col denaro, di infervorarli alle opere inique”.
Nel gennaio 1863 viene arrestata la principessa Barberini Sciarra Colonna mentre da Napoli si reca a Roma, sorpresa con lettere inviate dai legittimisti napoletani. Sembra di rivivere l’incubo del suo avo, Marco Sciarra, noto brigante, terrore dei cittadini romani ed abruzzesi.
Tra le gesta dei briganti più famosi, di cui non si riusciva ad oscurare l’alone di leggenda, si annovera per l’appunto anche tale personaggio, che, nel 1590, alla testa di 1500 uomini – dei quali 600 a cavallo -, commise scorribande in tutto il Lazio e l’Abruzzo. Per sconfiggerlo occorse un’alleanza tra napoletani, toscani e le forze pontificie. Nel 1588, infatti, avendo già commesso numerosi delitti e danneggiamenti, fu costretto a rientrare definitivamente nello stato pontificio a causa della caccia scatenata contro di lui dai soldati napoletani guidati da A.Piccolomini, che scriverà di lui: “ La sua religione non lo imbarazza davvero, si riduce a una specie di fatalismo superstizioso dove al culto bizzarro per la madonna si associano senza scrupolo alcuno la depravazione e la ferocia”.
Nello stato pontificio i Papi Pio II, Giulio II, Pio IV, Pio V ordinarono repressioni e stabilirono pene severe per i briganti; Sisto V pubblicò la Bolla Hoc Nostri e la costituzione Alias Felicis contro di essi ed i loro sostenitori, ordinando di scovarli dovunque fossero, anche nelle chiese e nei monasteri.
E’ da sottolineare comunque come i briganti romani, il più delle volte, non sono nati per delinquere, ma come oscure e sofferenti persone che hanno torti da vendicare, o contadini ridotti ad una vita quasi bestiale – miserabili che muoiono di fame, impotenti, senza alcun diritto da far valere, interamente sottoposti all’arbitrio dei signori feudatari – che desiderano, per qualche anno almeno, saziare la fame e far scontare le offese subite per anni nei feudi sterminati dei principi di Santa Romana Chiesa.
Sisto V fu quello che ottenne di più: severo, critico delle debolezze dei suoi predecessori, seguì tutt’altra politica. Conscio della debolezza dello Stato, che non aveva sufficienti forze per la caccia ad oltranza a tutti i briganti – ben protetti nelle foreste, nei boschi dell’Alto Lazio e della Ciociaria ed avvertiti tempestivamente da una fitta rete di spie e manutengoli -, li colpì nella loro stessa forza. Ordinò ai baroni ed ai Comuni di non tollerare più banditi nei loro castelli e nei loro territori, altrimenti i danni da questi arrecati sarebbero stati addebitati al Comune d’origine o al signore nel cui territorio si era verificato il fatto. Inoltre, ordinò che la taglia posta su un brigante fosse pagata non dallo Stato ma dalla famiglia di questo o, in caso di estrema povertà, dal comune del quale era oriundo. E’ chiaro che una siffatta politica mise contro i briganti le stesse persone che formavano la base d’appoggio delle loro azioni. In tal modo essi si ritrovarono a doversi salvaguardare non solo dagli sbirri pontifici, ma da tutti gli abitanti del paese dove operavano o si nascondevano, persino dai loro stessi familiari. Da notare come, nel 1865, furono destinati alle lotta contro il brigantaggio addirittura interi reggimenti di fanteria di Zuavi pontifici e di Carabinieri esteri e fu organizzato dal maggiore della gendarmeria, Conte L.Lauri, un corpo di “Squadrigliori”.
Ai briganti L.Robert ha conferito “una giacchettina piuttosto attillata, una metà delle gambe avvolta in un paio di pantaloni corti di velluto, l’altra metà intrecciata da una quantità di fasce e legature complicatissime, alle quali tutti i briganti sembrano così affezionati”. Ma né Robert né i turisti forestieri in cerca di emozioni sanno che il costume di tali personaggi, così pittoreschi, altro non è che quello dei contadini di Sonnino e Frosinone.
Il brigante romano difficilmente è crudele e sanguinario, uccide chi lo tradisce o per preservare la propria vita; piuttosto è propenso alla burla, al tiro audace e spiritoso.
Qualche brigante si convertì veramente, come il famosissimo Barone di Velletri, uno dei tanti matricolati che ottenne personalmente dal Papa perdono e clemenza; o come il Carmagnola che, perdonato, divenne commendatore e habituè del caffè Greco in via Condotti. Più che briganti questi sono annoverabili come delle “mezze tacche”; vedesi il Vendetta da Velletri che taglieggiava e ricattava gli abitanti della cittadina e delle vicinanze compresi i contadini dell’Agro, tassandoli per due, cinque, al massimo dieci scudi, ma che si stancò della vita che conduceva e tornò ad un’esistenza normale con un modesto ma sicuro reddito.
Il papa Sisto V, volendo estirpare definitivamente questa malerba, con un editto promise anche premi a favore di chi avesse aiutato la giustizia a catturare i briganti: 300 scudi di taglia se catturato vivo, 500 scudi se consegnato morto, oltre alla libertà se il delatore era un brigante “pentito”.
La collusione tra potere politico e onorata società era comunque denunciata quasi quotidianamente dalla stampa liberale che chiedeva maggior attenzione nella lotta contro la violenza dei banditi. Un generale preposto alla repressione scrisse: “…nei briganti, è personificata la protesta incessante delle classi diseredate, della povera gente che vorrebbe vivere di lavoro e invece non può trarne il necessario, sebbene sia soggetta a guisa di schiavi ai ricchi signori…”.
Il perché la bassa gente si scrollasse di dosso il giogo degli oppressori ricorrendo spesso alla violenza, per poi raggiungere alla macchia la moltitudine dei fuorilegge, Stendhal lo sapeva benissimo, vivendo ormai da molti anni in uno Stato che amministrava i suoi sudditi alla stessa maniera delle bestie. E, d’altra parte, ne aveva trovata limpida conferma in un sonetto di G.G.Belli del 1832 (Li soprani der monno vecchio) che ben si adattava all’attualità della situazione sociale dell’Italia in genere e dello Stato Pontificio in particolare, nel quale “li soprani” – ovvero il papa e il re – facevano della giustizia un “perpetuo arbitrio” e misuravano i valori morali “sul numero dei pater nostrer e delle avemmarie”, come scrivono Montanelli e Nozza in Garibaldi (1963).
In una situazione generalizzata di miseria, di mentalità violenta, vendicativa e provocatoria, si riscontrava un problema non meno importante: la lotta per l’egemonia che la borghesia stava conducendo contro la nobiltà rurale. Ma i briganti non capivano né Mazzini né i Bandiera: erano diminuiti nel periodo dal 1830 al 1850, ma non erano scomparsi. La polizia era dovunque più efficiente, le liste dei possibili delinquenti erano aggiornate continuamente, bastava un nulla per esservi iscritti. Alle schiere di attendibili si aggiungono schiere di contadini che occupano terre demaniali o baronali; persino un principe di casa reale, il Conte d’Aquila, fratello del re, era solito sobillare contadini e nullafacenti pur di dimostrare la politica inconcludente del fratello. Ma la civiltà non ebbe presa su di loro; pastori e boscaioli non ebbero spesso altro rifugio che capanne di legno o di paglia molto simili a quelle dei nomadi arabi, altri, dediti all’agricoltura, si riunirono e si rinchiusero nei villaggi arroccati su creste e picchi isolati, realtà molto pittoresche per gli occhi del paesaggista, ma le cui miserabili casupole non paiono fatte per essere abitazioni umane. In quest’ambiente crescono malandrini e briganti che, pur non organizzati in bande simili ad eserciti, come nell’epoca precedente, taglieggiano, rubano, sequestrano beni e persone. E’ un brigantaggio spicciolo, di pastori e contadini che s’imboscano, escono dalla macchia, fanno rapine ed estorsioni. Nella seconda metà dell’Ottocento furono 236 gli attacchi portati a segno da bande nell’area dell’Agro romano, caratterizzati da inaudita violenza, che non risparmiò neppure prelati ed anziani.
L’area in oggetto viveva in modo arretrato fra pascolo naturale e grano, e nello stesso tempo si presentava alle autorità e alla proprietà cittadina e nobiliare come un terra di frontiera, come un Far West casereccio. I briganti continuavano ad attestarsi principalmente nell’area dei Castelli romani, potendo dominare in questo modo le strade di maggior traffico come l’Appia, la Casilina, la Tiburtina nonché la Via Severiana, che permetteva il raggiungimento dell’Agro Pontino, vero e proprio quartier generale del brigantaggio laziale anche per mancanza di aree urbane in cui cercare solidarietà. Uno dei più noti briganti che operarono o passarono nell’area dell’Appia Antica, fu Beppe Mastrilli, il famoso “Terrore di Terracina”.
Scrissero di loro G.Salvemini, R.Villari, F.S.Nitti, L.Capuana, A.Dumas e Stendhal. Quest’ultimo, in particolare, attraverso gli scritti Racconti Romani e La Badessa di Castro, riuscì a rendere, con toccanti suggestioni, l’atmosfera brigantesca. Molte ballate, sonetti e versi sulle gesta dei briganti furono riportate sulle famose “pellicciaie”, cioè trascrizioni effettuate dai pecorari (o venditori di pellame e di merce varia, provenienti soprattutto dalla provincia di Macerata) e tramandate anche oralmente di generazione in generazione. Ben pochi di questi canti campagnoli rivestono propriamente la forma dialettale e questo fa credere che siano derivati da altre contrade d’Italia, come la Toscana, ad esempio, vera e propria fucina di poeti a braccio, ricca di autori delle “ballate” che hanno divulgato la leggenda; più che i misfatti è il clamore spesso ingigantito all’estremo che creava il mito.
A Stendhal, attento osservatore di tutto quello che accadeva nelle terre papaline e, dunque, anche della malavita boschereccia, erano note le simpatie che i ceti proletari riservavano ai briganti (“…in fondo, il cuore dei popoli era dalla loro parte…”), l’omertà, la protezione, la disponibilità servizievole di cui questi godevano (eccetto i malfattori integrali), specialmente se assurti agli onori della popolarità. Essendosi interessato alla vita e alle gesta del famoso Gasparone (Antonio Gasparone di Sonnino), che espiò molti anni di galera nella fortezza di Civitavecchia prima di essere trasferito nelle carceri di Spoleto e di Civitacastellana, finì quasi col diventare geloso della sua fama. Scrivendo ad un amico nel 1848 (il fuorilegge era chiuso nel carcere della città portuale pontificia dal 1826) si lamentò, infatti, perché “su cento stranieri che passano di qui, cinquanta vogliono vedere il celebre brigante Gasparone, e quattro o cinque M. de Stendhal”. Dunque le gesta del bandito laziale avevano propagato i loro echi oltre i confini nazionali e molti visitatori della Città Eterna sentivano il desiderio di tornare in patria con nella mente e negli occhi l’immagine del brigante che, evidentemente, non consideravano un volgare assassino, ma un protagonista di quell’opposizione al dispotismo di cui Henry Beyle non aveva fatto mistero nei suoi scritti. Egli, infatti, aveva messo in evidenza il prestigio di cui i briganti godevano, temuti e circondati da una sorta di rispetto nella pratica quotidiana del terribile diritto che si erano arrogati: quello di mettersi contro il potere costituito, ribelli alle leggi inique che lo sostenevano e che costituivano, per la povere gente, una croce troppo pesante da trascinare lungo il calvario di una vita impossibile. Un prestigio che talvolta sfiorava la semideificazione e che conferiva alle imprese dei briganti entrati nella leggenda (il Gasparoni, appunto, Stefano Pelloni detto il “Passatore”, Domenico Tiburii, Michele Pezza, Salvatore Rapisarda, Carmine Crocco, Tommaso Rinaldini della Isolabella e via dicendo) i caratteri del grande coraggio, dell’intrepidezza, dell’eroismo. Ecco il motivo per cui – parole di Stendhal – gli italiani leggono abitualmente piccoli poemi dove sono rievocate le circostanze degne di rilievo relative alla vita dei più famosi briganti.
Nota, infine, alla cronaca la processione popolare lungo l’Appia Antica da Velletri a Roma che si formò per osservare, quando furono condotti nelle patrie galere, gli uomini della banda di Gasperoni. Il ricordo del brigante, divenuto noto per il rapimento di otto frati avvenuto nel giugno del 1817 nella Certosa di Frascati, rimase vivo per anni e molti furono i voti espressi per la salvezza dei suoi uomini alla madonna del Carmine, nota come la madonna dei briganti. La banda Gasperoni il 23 settembre 1825 fu annientata: gli 8 arrestati, seguendo la strada da Priverno a Cisterna e da qui ad Ariccia, giunsero a Roma dove furono condotti immediatamente in Castel Sant’Angelo. Essi “erano soliti indossare un cappello a cono, alto, con tese strette, cinto da nastri multicolori, ma senza alcuna intenzione di farne un simbolo repubblicano. Giacca, gilet – un po’ più corto della stessa, con cinque file di bottoni d’argento, quella in mezzo per chiudere, le altre per puro ornamento – e pantaloni di velluto blu corto in tutte le stagioni. Il pantalone fino al collo del piede, la giacca del capobanda interamente bordata di galloni d’argento. Al posto delle scarpe le ciocie, genere di calzature simili a quelle degli spagnoli e a quelle che i pittori mettono a San Michele Arcangelo, con nastri di canapa assicuranti la calzatura alla gamba”.
Comunque la cronaca vuole che l’avvenimento più importante, riportato anche dalla stampa europea, fu l’audace colpo del “Passatore” ai danni di Pio IX durante una funzione religiosa in Castel Gandolfo. Si racconta che uno strano predicatore andasse in giro per la chiesa a far questua, tra l’altro con abbondante ricavato, come riportato da voci di popolo. Il monaco altro non era che il famoso brigante, il quale riuscì a mettere alla berlina il sommo pontefice noto fra la popolazione romana come “er papa tozzo”.
Ma tali gesta non saranno mai dei segnali di richiamo per i romani che, anzi, rimarranno quasi sempre alla finestra ad osservare quanto accade. Inoltre, il Brigante a Roma è essenzialmente un malfattore; non è protetto da nessuno, non porta sul petto le medaglie di Ferdinando o sul cappello la coccarda borbonica come i suoi confratelli dell’estremo sud.
Famosi, infine, sono i ritratti di scene di osterie e briganti di Goethe, Stendhal, Gogol e Pinelli che, facendo tappa presso tali locande fuori porta, testimoniano l’esistenza, le usanze, e soprattutto il fascino di questa gente: come, ad esempio, la bellezza delle donne popolane che venivano chiamate nelle case aristocratiche o borghesi per fare da balie ai giovani rampolli della Roma bene. Ed è fra queste osterie e stradine di campagna che vengono scritti gli stornelli più belli, con ammiccamenti politici (l’area dell’Appia Antica è collegio politico di Leone Caetani nell’epoca post-unitaria) e complimenti a belle donne, tra i quali quello in onore di Nannina dall’avvenenza straordinaria, riportata nella famosissima canzone Gita a li castelli. Passano e soggiornano fra le stanze della locanda dei Cessati Spiriti le gesta del brigante Giuseppe Mastrilli, il brigante di Terracina, che vengono vendute su fogli per turisti e cantastorie. Nel 1815 la più nota “cantata” era, per l’appunto, la storia di tale brigante, di scarsa poemicità, ma di grande emozione, alla quale si aggiunsero le ballate a Francesco Rossi, noto come Giggetto Romano, e Domenico Menichetti, che le cronache dipingevano come segue: “dotato di forza erculea, nei suoi delitti si è dimostrato sanguinario all’eccesso e di crudeltà inaudita, fido compagno di Fortunato Musoni, ha sparso il terrore per circa cinque anni nell’Agro R omano”.
Il Brigantaggio romano è vinto dall’emigrazione più che dalla forza della legge, dall’inurbamento più che dalla giustizia, e, soprattutto, dalla stanchezza: non era, infatti, possibile continuare a vivere in un’eterna rivolta che finiva sempre, prima o poi, con la galera o con la forca, mentre i manutengoli, gli informatori, i protettori a Roma s’arricchivano, prima con le loro imprese, poi con la cattura….con tali affermazioni terribilmente conclude Carlo Tuzzi il suo eloquente testo relativo al brigantaggio.