di Pasquale Grella e Christian Kiferle
Nella Campagna Romana una pratica zootecnica, tipica della tradizione pastorale, era rappresentata dalla transumanza; attività oggi quasi scomparsa. Si trattava dello spostamento delle greggi dalla pianura alla montagna durante il periodo estivo, quando le pecore cominciavano a partorire in maniera scalare, dalle più anziane fino alle più giovani.
Tale pratica aveva lo scopo non solo di spostare i capi verso luoghi più freschi ma soprattutto di offrire nuovi pascoli, più rigogliosi dal punto di vista nutrizionale della qualità del foraggio. Quelli più produttivi per l’attività zootecnica erano ben noti ai pastori della zona, i quali essendo sempre a stretto contatto con il gregge, conoscevano in maniera accurata la dislocazione dei terreni per il foraggio e le esigenze alimentari dei capi che pascevano sugli appezzamenti. Anche il pastore subiva il medesimo spostamento insieme al gregge e trovava riparo in vecchie e fatiscenti capanne, costruite appositamente per creare un rifugio di fortuna. In alternativa, la dimora permanente era rappresentata da antiche grotte scavate nella roccia dagli agenti atmosferici.
Quando si avvicinava l’inverno, che con le sue condizioni metereologiche sfavorevoli comprometteva l’integrità sanitaria dei capi e la produzione del foraggio per il bestiame, i pastori si apprestavano a spostarlo dalla montagna verso il fondo valle, ricreando il fenomeno inverso della transumanza. Qui, dove le condizioni climatiche risultavano più favorevoli per l’allevamento del bestiame e soprattutto per le pecore che stavano partorendo, il pastore era dedito soprattutto ad apportare le prime cure ai giovani agnelli, nati sia durante la transumanza che nelle stalle. Il fenomeno dei parti delle pecore generava due vantaggi molto rappresentativi ai fini della continuità dell’attività pastorale: il primo era quello della nascita degli agnelli che, dal punto di vista produttivo, rappresentavano quella quota parte di capi con i quali, una volta raggiunta la maturità riproduttiva, si andavano a sostituire le pecore più anziane; il secondo era costituito dalla produzione del latte, conseguenza fisiologica dei parti, che era fornito dalla mungitura delle pecore.Il latte rappresentava una risorsa naturale molto importante per il pastore, in quanto era l’elemento base, essenziale, nel processo che portava alla produzione del formaggio: veniva munto a mano, secondo la tradizione antica, per poi essere riversato in enormi calderoni posti sul fuoco, allo scopo di eliminare, con il processo dell’ebollizione, i microrganismi sfavorevoli alla caseificazione; mentre il latte si raffreddava il pastore aggiungeva all’interno del grande paiuolo l’ingrediente più importante per il processo di caseificazione, il caglio, cioè una parte dello stomaco dell’agnello di pecora o di capra; la fase finale dell’intero procedimento, per tradizione antica, portava alla produzione di una pasta filante e nutriente, pronta per essere conservata nelle grotte naturali dove subiva la maturazione e l’invecchiamento.
Il fenomeno dei parti delle pecore generava due vantaggi molto rappresentativi ai fini della continuità dell’attività pastorale: il primo era quello della nascita degli agnelli che, dal punto di vista produttivo, rappresentavano quella quota parte di capi con i quali, una volta raggiunta la maturità riproduttiva, si andavano a sostituire le pecore più anziane; il secondo era costituito dalla produzione del latte, conseguenza fisiologica dei parti, che era fornito dalla mungitura delle pecore.Il latte rappresentava una risorsa naturale molto importante per il pastore, in quanto era l’elemento base, essenziale, nel processo che portava alla produzione del formaggio: veniva munto a mano, secondo la tradizione antica, per poi essere riversato in enormi calderoni posti sul fuoco, allo scopo di eliminare, con il processo dell’ebollizione, i microrganismi sfavorevoli alla caseificazione; mentre il latte si raffreddava il pastore aggiungeva all’interno del grande paiuolo l’ingrediente più importante per il processo di caseificazione, il caglio, cioè una parte dello stomaco dell’agnello di pecora o di capra; la fase finale dell’intero procedimento, per tradizione antica, portava alla produzione di una pasta filante e nutriente, pronta per essere conservata nelle grotte naturali dove subiva la maturazione e l’invecchiamento.
L’attività lattiero-casearia così come quella orto-frutticola rappresentava nel comprensorio agricolo dell’Agro-romano l’unica fonte di sussistenza per la civiltà rurale. Il pastore riusciva a ricavare 1 kg di formaggio ogni 4-5 litri di latte in funzione della razza allevata. Infatti, a seconda della stessa, variavano le percentuali di grasso e proteine che incidevano sulle proporzioni di latte da utilizzare per la caseificazione.
Romolo Trincheri nel suo libro Vite di Pastori nella campagna romana così scrive: “I pastori romani, dalle più lontane epoche, in tutti i periodi della loro attività ciclica, sia nella famiglia che nella società, sia nella foggia del vestire che negli attrezzi ed utensili usati, sia nell’esprimersi che nel comportarsi, sia nell’esercizio della loro specifica industria che nelle varie contrattazioni tra loro e con terzi, sia nelle produzioni che nel commercio del frutto (formaggio, pelle, abbacchi, ecc…) osservano con particolare costanza quello che appresero di padre in figlio e improntano i loro rapporti sociali al rispetto della buona fede e al concetto del buon padre di famiglia, talmente da indurci a considerare la loro categoria un modello dell’osservanza della più pura tradizione e primitività di condotta e di vita”.
Quello che segue vuole essere una descrizione della figura del “pastore di transumanza”, tanto caro a poeti e pittori, che lo immortalarono nelle loro opere, consegnandolo alla storia.
Ringraziamo pertanto Gregorio De Santis, pastore di transumanza, che ci ha fornito gli spunti per questo scritto e tutti coloro che con il loro sacrificio hanno consegnato alla futura generazione un mondo fatto ancora di sogni, racconti e canzoni.
POCHE PECORE E MOLTA VIGNA,
L’UNA E’ LA VOGNE, E L’ALTRA E’ LA TIGNA
(Vecchio proverbio dei pastori)
Gregorio è un ex pastore che vive in un piccolo borgo che guarda il lago del Salto.
Ci ha raccontato la sua storia.
“…Ho iniziato a fare il pastore di transumanza a 10 anni. Ho svolto questo lavoro per 32 anni spostandomi da un paese all’altro, lungo sentieri antichi che collegavano Rieti con i centri della provincia di Roma e Latina.
Per arrivare a Roma si seguivano i sentieri di Vallecupola, Stipes, Neroli, Tivoli, Palombara. Quando finalmente si era a Roma si raggiungevano i centri di raccolta di RomaVecchia, Capannelle, Frattocchie.
Noi pastori, ospiti nelle proprietà private dei nobili romani come i Ludovisi Boncompagni, trascorrevamo le notti nelle cave (Santa Maria delle Mole) o nei casali (Roma Vecchia, Caffarella, Capannelle ed altri).
Per arrivare a Roma ci si impiegavano 3 giorni e altrettanti per raggiungere le aree marine di Aprilia e San Felice Circeo.
I nostri genitori ci hanno insegnato i “tratturi“, cioè le strade, da percorrere. Questi, ora, sono in gran parte scomparsi, sia per la riduzione della pastorizia di transumanza, sia perché le proprietà private impediscono gli attraversamenti.
Lungo la strada si faceva il formaggio e, grazie a quello, si poteva “pagare” l’ospitalità o l’attraversamento delle proprietà. Non era raro che il latte e il formaggio venissero barattati con il cibo cotto o con la paglia per il giaciglio notturno.
Quando era tempo buono si dormiva a cielo aperto, altrimenti in stalle e capanne. All’interno si sistemavano i posti letto in forma circolare, e li chiamavamo “rapezzole”.
Usavamo banchettare all’aperto, accoccolati a terra, cucinando attorno al fuoco.
I cibi preferiti tradizionali erano la “fagliatella“, cioè la parte più grassa dell’intestino dell’abbacchio, cotta sulla brace e la “pezzata“, carne di pecora tagliata a pezzi con l’aggiunta di lardo e cipolla, cotta nel “caldarello” a fuoco vivace.
La Valle del Sacco, prima che creassero il lago, era molto abitata ed ogni paese aveva una scuola. Anche qui a Rocca Vittiana c’era una scuola. L’unica classe era composta da 13 o 15 ragazzi. In tutto il paese c’erano oltre 50 persone, ora non più di 10.
Il percorso per arrivare a Roma non era sempre lo stesso. Variava rispetto ai luoghi di macellazione, di vendita del formaggio o dalla disponibilità di depositare il formaggio nelle “caciare“. Nella pastorizia il “caciaro” è la professione più importante dopo il “vergaro“. A lui il compito di predisporre la fabbricazione del pecorino e della ricotta.
Quando arrivavamo in città, entrando da Capanelle, Frattocchie o da Prima Porta, non eravamo ben visti dai cittadini e difficilmente entravamo in contatto con loro. Ci dicevano: “ecco i pecorari”.
Quando facevamo il formaggio, indossavamo un vestito fatto da noi con le pelli di pecora, una specie di tuta da lavoro. Questo vestito serviva per non sporcarci ed avevamo solo quello. Era il vestito per la mungitura. Lo indossavamo, la mattina molto presto, per la lavorazione del formaggio. Finito il tutto, lo toglievamo e con i vestiti di tutti i giorni si riprendeva il cammino.
Era bello quando, attraversando i paesi, la sera si poteva andare in trattoria oppure quando in primavera si andava a ballare dove si esibivano le orchestrine. Molte volte accadeva che qualcuno di noi veniva offeso perché “Pecoraio” o “Abruzzese”. Di conseguenza tendevamo a riunirci in gruppo, anche se non ci si conosceva, e ci si difendeva come possibile.
Una volta, ad Aprilia, accadde il finimondo. Uno di noi, dopo esser stato offeso, prese un bastone e cominciò a rompere tutte le lampadine della festa. Arrivarono, quindi, i carabinieri e ci fu il fuggi fuggi.
Questi fatti diventavano poi i “racconti” quando, tornati al paese, si faceva sera sulla piazza o mentre si giocava a carte. Qui si recitavano poesie a braccio come quella che fa:
Io sono Rinaldo e col bicchiere in mano mando saluti a tutti i presenti.
Pastori nati nell’alto Aquilano tra luoghi ameni e limpide sorgenti.
Che poi emigrati nell’Agro romano solo in custodia dei lamenti armenti.
Sperate come me giorni beati di tornare presto dove siamo nati.
Durante il giorno, a volte, entravamo furtivamente negli orti o nei campi per raccogliere qualcosa per cucinare durante le soste. Quando venivamo scoperti eravamo costretti a pagare quanto preso con del formaggio. Una volta, a Nerola, dovemmo produrre 7 Kg di formaggio per pagare dei broccoletti; la richiesta era esagerata, ma dovemmo pagare per evitare la denuncia alle autorità.
Il mangiare di noi pastori era povero. Mangiavamo quasi sempre il pane cotto che mettevamo a bollire con un po’ d’olio. Mangiavamo anche la “Paniccia“, cioè il pane con il siero di latte; poi le cipolle e la cicoria. Qualche volta potevamo prendere un po’ di ricotta o di formaggio, ma di solito non era possibile, perché quello che si produceva doveva essere venduto.
Molti di noi portavano con sé la famiglia perché il percorso era breve e, così, non si viveva isolati. Noi uomini frequentavamo le osterie dove si usava poetare a braccio, cioè improvvisare le poesie; a volte si svolgevano anche delle gare.
Noi pastori ci tramandiamo tradizioni antichissime, che si perdono nella notte dei tempi. Per noi è importante, ad esempio, fare il segno della croce sul bordo del contenitore dove si lavora il formaggio. E’ una forma di ringraziamento, di rispetto al Signore.
Quando tornavamo a casa dalla transumanza non avevamo più un solo bottone nei pantaloni e sulle giacchette. Li utilizzavamo per giocare: erano le nostre automobiline, le nostre biglie. Il nostro passatempo. Giocavamo anche durante la preparazione del formaggio.
Tutto era fatto con fatica, pochi erano i momenti di incontro collettivo. Quando si organizzavano delle feste, delle processioni o cose simili si partecipava con grande felicità.
Qui a Rocca Vittiana c’era un prete, padre Alessandro. Ora è ospite presso gli alloggi di S. Sebastiano in via Appia Antica. Lui ci invitava a partecipare anche alle feste organizzate in altri paesi. Erano le uniche volte che uscivamo dal paese non per motivi di lavoro.
Quanto lavoro, ma anche quante soddisfazioni…”.
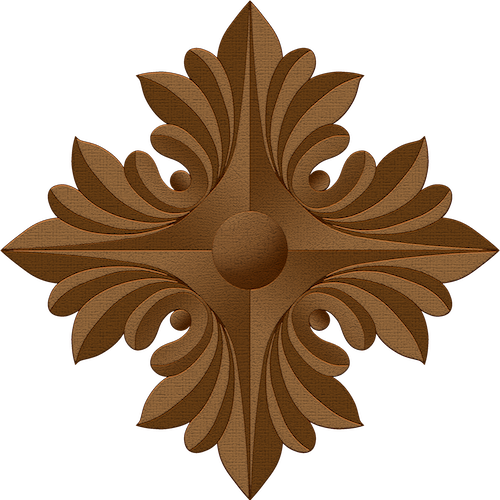





Storia di uno degli ultimi pastori a pascolare il proprio gregge all’interno del territorio di Roma (Tor di Quinto, vicino Ponte Milvio):
https://youtu.be/GHhjITsijRQ
Molto interessante. Sarebbe bello in questa pagina raccogliere tante storie di pastori