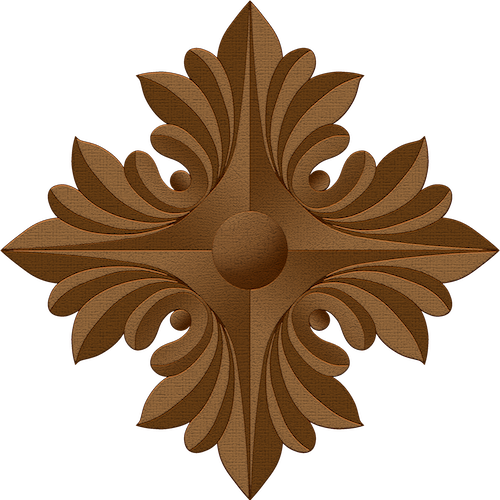di Ugo Mancini
di Ugo Mancini
I Castelli Romani non rappresentano un’estensione puramente geografica che raccoglie quasi algebricamente comuni più o meno distanti tra loro. L’ampio territorio che si estende a sud-est di Roma lungo la doppia dorsale della via Appia e della via Tuscolana ancora oggi presenta profondissime tracce di una cultura solidaristica e democratica che si è andata formando nel corso dell’Ottocento e del Novecento. Si tratta di una cultura articolata e complessa, dovuta ad una particolare concomitanza di fattori e maturata prevalentemente tra le classi subalterne in una lotta quotidiana e continua per il miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Uno dei fattori che hanno maggiormente inciso nel delineare i tratti della crescita civile delle popolazioni castellane è dato dalla vicinanza con Roma. Già all’inizio del Novecento Domenico Seghetti descrisse l’incidenza del mercato romano nell’orientare la produzione agricola dei Castelli Romani raccontando di campagne prevalentemente dedite alla frutticoltura, di una Frascati nota per le proprie mandorle e di numerose famiglie che dovevano la loro agiatezza al tradizionale commercio con Roma, che in certi periodi le costringeva «ad eseguire larghe incette delle varie specie di frutta in parecchi paesi della regione laziale». Nello stesso periodo e ancora nei primi decenni del Novecento il mercato romano della legna da ardere o da costruzione beneficiò i Comuni di Rocca di Papa e Rocca Priora. Nemi divenne invece famosa per i fichi, Albano per ortaggi e patate, Marino per i carciofi, anche se questi erano destinati in larga prevalenza all’industria conserviera napoletana.
Seghetti fu anche testimone delle profonde trasformazioni cui andò incontro la produzione agricola castellana a seguito dell’annessione del Lazio al Regno d’Italia. Con l’arrivo nella nuova capitale di prodotti a basso costo dal Mezzogiorno d’Italia, dal 1870 la frutticoltura divenne sempre meno redditizia lasciando il passo all’oleicoltura e soprattutto alla viticoltura. La sostituzione del commercio della frutta con quello del vino e dell’olio è di fondamentale importanza per comprendere la specificità del territorio castellano nel panorama laziale e la natura della evoluzione culturale, politica e civile delle sue popolazioni. Il mercato di riferimento fu sempre quello di Roma, capace di assorbire mediamente un terzo della produzione castellana di vino e di olio, come testimoniò Luigi Capri Cruciani, uno dei maggiori imprenditori agrari del primo Novecento. La coltura della vite aveva la prerogativa di richiedere stagionalmente una quantità di lavoro che superava di quattro volte quella necessaria per le superfici coltivate a grano. Al tempo stesso però consentiva di realizzare entrate che andavano ben oltre le spese sostenute per la produzione, giungendo in particolari annate, come quella del 1904, a «restituire al proprietario l’intero valore del fondo, con il frutto di una stagione!».
Sia nel periodo preunitario che in quello unitario la vicinanza del grande mercato romano fornì alle masse contadine la percezione di un possibile miglioramento delle proprie condizioni legato al possesso di un appezzamento di terra. Il passaggio dalla frutticoltura alla viticoltura rese poi questo desiderio e quest’aspirazione ancora più forte perché anche il possesso di un terreno di dimensioni limitate avrebbe potuto mutare sensibilmente le sorti di un intero nucleo familiare.
Il desiderio di una proprietà familiare nel periodo preunitario era stato frustrato dalle condizioni di sfruttamento cui erano soggette le masse contadine ad opera di una nobiltà agraria latifondista e spesso assenteista e da una concentrazione della proprietà terriera nelle mani di poche famiglie nonostante l’emanazioni delle leggi antifeudali che si registrò nella penisola a partire dal 1806.
Il legame dell’aristocrazia terriera con la Curia romana, l’essere quell’aristocrazia sostegno ad uno Stato pontificio orientato verso il rifiuto di ogni cambiamento e chiuso alle prospettive o alle eventuali invocazioni di un miglioramento delle condizioni di vita delle masse contadine, nei Castelli Romani contribuì ad accendere un crescente anticlericalismo. L’avversione nei confronti della Chiesa e del clero divenne in larga parte ferma contrapposizione al potere, ad un sistema economico-sociale che nella pratica sembrava contraddire i principi cristiani, ad unico vantaggio di una nobiltà ritenuta in larga parte «affamatrice». Il prete spesso fu visto come difensore dell’ordine tradizionale, vicino alle famiglie più influenti, come accadde ad esempio a Genzano con monsignor Antonio Cipressi e i Mazzoni, o addirittura complice dei proprietari terrieri nel suonare il ritardo l’«Ave Maria» per allungare la giornata lavorativa degli ignari contadini.
Le aspirazioni patriottiche e risorgimentali si fusero con la speranza e spesso con la ferma convinzione che l’abbattimento dello Stato pontificio avrebbe favorito quasi meccanicamente la costruzione di un sistema più giusto e meno iniquo. L’anticlericalismo si incontrò in tal modo con il mazzinianesimo, che si diffuse largamente tra la popolazione castellana per la proposta di un progetto politico che andava al di là della semplice unificazione dei territori della penisola e che rendeva il popolo protagonista non solo nella creazione di un nuovo Stato unitario e repubblicano ma anche del proprio riscatto sociale. Nella fiducia che l’abbattimento della «Roma dei Papi» avrebbe consentito la nascita della «Roma del popolo», numerosi castellani corsero in difesa della Repubblica romana del 1848-49, parteciparono alla spedizione dei Mille e presero parte all’insurrezione di cui fu teatro Roma nel 1867.
Il legame tra le aspirazioni patriottiche e un concreto bisogno di cambiamento politico, morale e civile negli anni Settanta del XIX secolo è attestato anche dalla comparsa di numerosi circoli e giornali di ispirazione repubblicana e dal grande consenso che si coagulò attorno a Garibaldi in occasione di alcuni comizi che tenne a Frascati, Velletri, Albano e Ariccia nel 1875. Garibaldi era stato il grande condottiero di epiche battaglie risorgimentali, ma egli ormai era il deputato, l’eroe del Risorgimento che preferiva definirsi «agricoltore», che affrontava temi come il progresso, la civiltà e il lavoro e che indicava con forza e schiettezza di linguaggio i limiti dell’unificazione appena realizzata, affermando tra l’altro che «se l’Italia avesse un governo quale si conviene, i preti colla vanga in spalla sarebbero occupati nella bonifica delle paludi pontine» e che «il risanamento dell’Agro Romano, e la sua riduzione a buona cultura, sono intimamente legati all’onore e all’avvenire non solo di Roma, ma dell’Italia tutta, potendo questo essere il principio del miglioramento generale dell’agricoltura italiana e quindi del risorgimento economico della Nazione».
Nei primi decenni di storia unitaria la nobiltà terriera era però riuscita a conservare quasi inalterato il proprio potere. Di fronte alla diffusione del mazzianianesimo e alla rilevanza che nell’impegno patriottico aveva assunto per le masse lavoratrici la questione sociale, la nobiltà trovò un importante alleato nella forte borghesia rurale che si era andata formando negli ultimi decenni. Una nuova élite, composta da grandi e medi proprietari terrieri, avvocati e commercianti, si pose accanto alla nobiltà tradizionale con il preciso intento guadagnare visibilità e potere e di tutelare i propri interessi e i propri privilegi dalle rivendicazioni e dalle animosità che si erano diffuse tra la popolazione rurale per la delusione prodotta da un’unificazione senza reali cambiamenti.
La presenza di forze economiche e politiche di chiaro orientamento conservatore nei diversi comuni dei Casatelli Romani consentì alle famiglie nobiliari degli Aldobrandini, dei Borghese, dei Chigi, dei Ferraioli, dei Lancellotti di concentrare attenzione e risorse sulle opportunità che offriva la trasformazione di Roma nella capitale del nuovo regno. Mentre le amministrazioni locali divenivano appannaggio di potentati familiari di estrazione borghese, con il concorso di un sistema censitario che escludeva dal voto la stragrande maggioranza della popolazione, la stessa nobiltà che per secoli aveva sorretto lo Stato pontificio poté penetrare nelle maglie dell’amministrazione della Capitale. Nel 1880 ben 16 casate nobiliari erano rappresentante in seno al Consiglio comunale romano. Tra di esse vi erano i Borghese, gli Aldobrandini, i Chigi, i Torlonia, i Ferraioli e gli Sforza Cesarini.
Più o meno nello stesso periodo si andarono consolidando nei Castelli romani delle egemonie destinate a segnare la vita dei rispettivi comuni per lunghi decenni, tormentati da una gestione affaristica delle cariche pubbliche anche in palese presenza di gravi conflitti di interesse. A Genzano imperarono, finanche nel periodo fascista, le famiglie Mazzoni, Giannini, Fagiolo. Stessa situazione si creò a Rocca di Papa con i Santovetti e i Fondi, a Frascati con i Bernaschi, i Romalli, i Di Mattia, a Castel Gandolfo con i Costa, a Montecompatri con Mario Mastrofini, a Marino con Luigi Capri Cruciani. Molti fra costoro andarono a comporre una cordata politico clientelare che si formò tra Otto e Novecento attorno al deputato Francesco Aguglia e al suo successore Domenico Valenzani e che agì sull’intero territorio, protraendosi con pochi cambiamenti nel Ventennio fascista, costruendo una stretta relazione tra affari, voto elettorale e amministrazione cittadina.
In tal modo, nonostante l’unificazione e la caduta dello Stato pontificio per mezzadri e braccianti gli orari e i carichi di lavoro continuarono ad essere massacranti, i salari e i redditi non ridussero la gravità dello sfruttamento preesistente, e il collocamento continuò ad essere organizzato arbitrariamente, a totale vantaggio dei proprietari e di mediatori con pochi scrupoli. Ciò rafforzò nella popolazione contadina il desiderio ed il bisogno di un vero cambiamento e rese prevalente la tendenza ad abbracciare dottrine che annunciavano o teorizzavano rinnovamenti radicali in campo economico e politico.
Nel tardo Ottocento le élite locali non poterono ignorare le condizioni drammatiche in cui versavano le masse popolari. Esse affrontarono però la questione sociale in maniera paternalistica, attraverso la costituzione di Società di mutuo soccorso. A Frascati nel 1871 nacque la Società operaia cattolica tuscolana che contò 350 iscritti; nel 1873 a Genzano Francesco Sforza Cesarini organizzò la Società agricola di mutuo soccorso che contò 112 iscritti; nel 1879 vennero fondate a Rocca di Papa la Cattolica mutuo soccorso con 45 soci, a Velletri la Società Agricola Veliterna, con 11 soci, a Marino l’Operaia mutuo soccorso arti miste, che arrivò a contare 362 iscritti; nel 1882 ad Albano nacque la Società operaia di mutuo soccorso con 133 soci, mentre ad Ariccia ne nacque una contadina. Si trattava di organizzazioni che riconoscevano lo stato di miseria e di necessità in cui versavano le classi più deboli ma che non avevano come obiettivo il riconoscimento di diritti e una riorganizzazione della società in maniera meno squilibrata.
Anche il mondo cattolico accentuò le proprie divisioni di fronte alla grave assenza nei programmi di governo di una seria politica sociale. Divisi tra quanti rifiutavano il nuovo regno d’Italia e sognavano la restaurazione dello Stato pontificio e quanti ritenevano si dovesse trovare un modo per riaffermare i principi cristiani e il ruolo della Chiesa nella nuova situazione, a fine Ottocento molti cattolici cominciarono a prendere atto delle ingiustizie sociali che produceva il sistema e della corruzione dilagante nel paese e soprattutto attorno alla politica. A fronte di quanti si resero partecipi della nascita e sostennero le Società di mutuo soccorso, nei Castelli Romani altri cattolici fecero scelte più radicali, spesso mettendo a rischio l’alleanza tra clericali e moderati.
A cavallo dei due secoli l’indebolimento dell’intransigentismo cattolico fu accompagnato da un’ampia diffusione degli ideali della Democrazia cristiana propagandati da Romolo Murri. Lo sforzo compiuto dai democratici cristiani di individuare una terza via tra socialismo e liberalismo, capace di realizzare le condizioni per «una vera democrazia», conforme «ai principi sociali del cristianesimo», concorse a sollevare da un’altra prospettiva la questione morale e ad aumentare la credibilità e a dare maggior fondamento alle accuse di malgoverno e corruzione rivolte alla politica locale e nazionale da radicali, repubblicani e socialisti. Agli inizi del Novecento nacquero diversi circoli democristiani specie sul versante tuscolano dei Castelli Romani, ma nel primo decennio del secolo si andarono formando vere e proprie alleanze tra cattolici, repubblicani, radicali e socialisti per sconfiggere il sistema affaristico e clientelare edificatosi attorno al deputato Aguglia sia nelle elezioni amministrative che in quelle politiche.
Le masse esclude dal diritto di voto nel corso dell’ultimo quarto dell’Ottocento maturarono un crescente risentimento nei confronti dello Stato unitario. Esso aveva tradito le attese più forti, quelle che riguardavano un profondo rinnovamento sociale e civile. Per molti patrioti quella che avevano davanti era l’Italia di Cavour e di Vittorio Emanuele e non quella di Mazzini, Cattaneo o Garibaldi. La politica mostrava i segni di una grave corruzione e si prestava spesso platealmente a soccorrere i potentati locali nel conservare le tradizionali forme di sfruttamento del lavoro agricolo.
Nel giugno del 1888, pochi giorni dopo l’emanazione dell’enciclica Libertas, in cui papa Leone XIII ribadiva la condanna del liberalismo, fu emanata una legge che assegnava i terreni soggetti ad uso civico alla parte che ne vantava il possesso dietro il riconoscimento di un compenso agli utenti. Si trattò di un provvedimento che incise profondamente nella storia della formazione civile e politica delle masse lavoratrici castellane. Quel provvedimento assegnava a giunte comunali composte largamente da proprietari il compito di decidere il futuro di terreni contesi alla popolazione. Nel Lazio tra il 1888 e il 1904, con la compiacenza di Giunte arbitrali e tribunali e con il pagamento di indennizzi irrisori furono sottratti, a popolazioni drammaticamente bisognose, diritti di semina, di pascolo o di taglio nelle zone boschive su oltre 70.000 ettari di terreno.
Come sottolinea Caracciolo, l’orientamento classista fu condannato anche da alcuni proprietari e al termine del primo conflitto mondiale Guido Brigante Colonna e Gino Cartoni, nella loro relazione al Congresso Nazionalista laziale del 21 dicembre 1919, imputarono proprio all’iniquità della legge del 1888 la responsabilità delle invasioni di terre che i contadini poveri organizzarono tra il 1905 ed il 1907. Lo stesso ministro Rava nel 1905 ammise che nonostante l’arbitrarietà delle invasioni, dietro la coltivazione delle terre contese da parte degli utenti vi poteva essere essenzialmente «il bisogno di esercitare un legittimo diritto».
L’uso strumentale del potere da parte delle classi agiate e la stanchezza della popolazione per una politica nazionale e locale distante dalle necessità della maggioranza, nei Castelli Romani contribuì in maniera decisiva a sospingere il mondo contadino ad abbracciare una concezione classista della società e della lotta politica. Nel corso degli anni Novanta del XIX secolo la dottrina socialista si diffuse con crescente facilità a volte armonizzandosi e persino confondendosi con il repubblicanesimo, a volte favorendo alleanze strategiche in cui non si perdevano gli elementi di differenziazione, altre volte determinando lo spostamento di interi gruppi di repubblicani su posizioni più conservatrici, come accadde ad esempio a Frascati. Nel 1896 a Marino si svolse il I Congresso socialista romano in cui cinque circoli socialisti su dieci erano dei Castelli Romani. L’anno seguente nacque a Genzano la prima lega di resistenza e il possesso della terra cominciò a divenire oggetto di rivendicazione nel corso delle manifestazioni popolari. A seguito di proteste e agitazioni i contadini di Colonna riuscirono ad ottenere in enfiteusi i terreni di Valle Canestra, quelli di Albano e Ariccia le terre di Santa Palomba e di Cancelliera, nel 1898 quelli di Marino ottennero analoghe concessioni dai Colonna. Nel 1901, nonostante la durissima repressione delle proteste per il rincaro del pane del maggio 1898, che a Genzano era costata la vita a due contadini, nuove agitazioni si verificarono a Marino, Rocca di Papa, Montecompatri, dove circa 400 contadini invasero delle tenute di proprietà dei Borghese e dei Rospigliosi, ottenendo 40 rubbia in enfiteusi, e a Colonna, dove la rivendicazione del possesso della terra ebbe come risposta l’intervento della cavalleria.
Tali agitazioni non furono solo frutto della propaganda socialista. Si trattò per lo più di iniziative isolate, occasionali, ispirate dalla fame e dalla miseria e determinate da episodi e opportunità che si imposero localmente, senza coordinamento con quanto accadeva altrove e soprattutto del tutto scollegate da quanto si andava discutendo ed elaborando a Roma tra gli organi direttivi del Partito socialista. D’altra parte nel 1901 esisteva ancora solo la lega contadini di Genzano e solo nel 1902, dopo un’annata di cattivi raccolti, nacquero leghe di lavoratori anche a Marino, Frascati e Montecompatri.
Nel 1903 le occupazioni di terre ripresero e si ripeterono a Colonna, dove fu invasa la tenuta Pallavicino, ad Albano, dove una nuova invasione della tenuta Cancelliera fece ottenere ai contadini 50 ettari che furono coltivati in cooperativa, ad Ariccia, dove 300 contadini si radunarono di notte al suono delle campane e iniziarono a vangare parte della tenuta Vallericcia. Tra il 1906 ed il 1908 le invasioni di terre nei Castelli Romani assunsero una carattere popolare e più che di un’eversione assunsero i toni della festa, i caratteri di una gioiosa riaffermazione di principi che mobilitò interi paesi a sostegno della causa contadina, o il più cupo e drammatico profilo della vertenza sindacale attorno alla richiesta di miglioramenti salariali, della riduzione della giornata lavorativa, o dell’istituzione di un collocamento che impedisse ai proprietari di ricorrere ad una più economica manodopera forestiera. Se nel 1906 vi furono così circa 4.000 persone che da Rocca di Papa si mossero «processionalmente» verso la località Vivaro, di proprietà di Vittoria Colonna e del duca Sforza Cesarini, accompagnate dal suono delle campane, cantando inni patriottici e con circa 300 popolani a cavallo a chiudere il corteo, a Genzano centinaia di contadini si avvicinarono alla Lega di resistenza, organizzando o partecipando in massa a proteste e astensioni dal lavoro, come accadde nel 1908 con uno sciopero cui aderirono circa 1.400 vignaroli.
Proprio a Genzano la Lega contadini ottenne un risultato destinato a rimanere storico. Mentre altrove si continuava a lavorare nei campi dall’alba al tramonto, i contadini nel gennaio del 1908 riuscirono a far porre per iscritto nel rinnovo dei contratti di lavoro la riduzione della giornata lavorativa a sei ore.
Le battaglie per la terra o per il riconoscimento di diritti e tutele sul piano strettamente lavorativo furono accompagnate da intense battaglie politiche contro amministrazioni corrotte e schierate classisticamente. A Montecompatri un’alleanza tra socialisti e democratici cristiani nel 1902 interruppe la lunga e assai discussa sindacatura dell’agugliano Giovanni Felici e nel 1903 portò alla guida del municipio il socialista Placido Martini. Ad Albano analoghe coalizioni aiutarono il partito socialista nel 1903 a sconfiggere il sindaco agugliano De Rossi e tra il 1910 e il 1911 il suo compagno di cordata Silvestroni, stabilendo un’egemonia che con Luigi Sabatini e Dante Malintoppi si protrasse fino all’avvento del fascismo. A Genzano i socialisti, guidando una coalizione popolare, nel 1910 posero fine alla lunga e incontrastata egemonia della famiglia Mazzoni e tre anni più tardi portarono alla guida del municipio il presidente della lega contadini Tommaso Frasconi. Nel 1914 anche a Rocca di Papa, fino ad allora dominio di tenaci famiglie proprietarie di industrie di legami, i socialisti conquistarono il municipio con Luigi Sciamplicotti.
Tranne la conquista delle sei ore, che si protrasse persino sotto la dittatura fascista, le altre battaglie conseguirono successi solo temporanei. I miglioramenti salariati e l’istituzione del collocamento furono sin da subito messi in discussione dal sistematico ricorso alla manodopera forestiera. Le controversie legate al possesso della terra invece furono faticosamente e dolorosamente messe tra parentesi dall’inizio del primo conflitto mondiale, mentre la vittoria socialista in alcuni comuni fu cancellata da immotivati commissariamenti, come a Genzano, dal ritorno delle forze conservatrici agevolato dalla crisi bellica, o dall’avvento del fascismo, come accadde ad Albano.
La consapevolezza dell’importanza delle conquiste realizzate, la percezione della loro provvisorietà e la sensazione che molto si dovesse ancora realizzare per guadagnare condizioni di vita più dignitose, contribuirono a diffondere nei Castelli Romani un acceso pacifismo, a far maturare una posizione fermamente contraria al primo conflitto mondiale e, laddove non ci fu contrarietà ed esplicito antimilitarismo, fu raro vi fosse qualcosa di più di una rassegnata consapevolezza di una lontana eco con cui prima o poi si sarebbe dovuto fare i conti.
La guerra in effetti interruppe la progressiva crescita del mondo contadino e il rafforzamento delle organizzazioni ad esso collegate creando un grave spartiacque rispetto al periodo precedente. La fine del conflitto riportò tuttavia con ancora più netta drammaticità la terra, e con essa i salari, la giornata lavorativa e il collocamento, al centro dell’attenzione delle masse contadine e nel cuore dei programmi dei partiti e delle organizzazioni dei lavoratori. Con il concorso delle classi dirigenti, dopo Caporetto aveva cominciato a circolare tra i fanti contadini la promessa che al ritorno dal fronte sarebbe stata concessa loro la tanto agognata terra. La Federterra già nell’aprile del 1917 si mobilitò per «deviare le lusinghe demagogiche e le vaghe promesse dei numerosi gruppi e partiti che vogliono accaparrarsi la benemerenza delle classi agricole». Mentre dalla Russia giungevano con ritmo sempre maggiore notizie di una rivoluzione che aveva abbattuto la proprietà privata e che attraverso la collettivizzazione stava elevando le masse lavoratrici al ruolo di protagoniste della vita politica e sociale del paese, i partiti della sinistra e la Federterra ribadivano con forza crescente il valore sociale della terra e condannavano l’abbandono dei campi e l’assenteismo dei proprietari.
Dopo una ripresa delle occupazioni di alcune tenute di proprietà nobiliare verificatasi nel 1917, appena si concluse la guerra il fenomeno delle invasioni di terre nei Castelli Romani assunse vaste dimensioni trovando un’amplificazione della propria portata nella vicinanza con la Capitale. I contadini di ritorno dal fronte però furono costretti anche a riprendere il filo delle loro rivendicazioni dal punto in cui il conflitto le aveva interrotte. Tornarono così a ripetersi le proteste e gli scioperi per i miglioramenti salariali, per la durata della giornata lavorativa, contro l’utilizzo dei forestieri, o persino dei prigionieri di guerra, come avveniva da parte di numerosi imprenditori agrari di Frascati, Monte Porzio, Castel Gandolfo, Ariccia e Albano.
Nell’aprile del 1919 anche a Frascati la lega contadini sottoscrisse un contratto che riduceva la giornata lavorativa a sette ore e che fissava la paga oraria in £. 3,00 per i lavori di vangatura, zappatura e acqua ramata. Si trattava di una conquista importante ma che, come le altre del periodo, fu resa debole dal massiccio ricorso alla manodopera forestiera da parte dei datori di lavoro.
Da gennaio ad aprile del 1919 si era inoltre verificata la prima delle tre ondate di invasioni di terre che posero i Castelli Romani nel vivo di un fenomeno che stava investendo l’intera penisola. I proprietari terrieri cercarono di tenere alto lo scontro parlando di attentato alla proprietà, denunciando presunti danni alle colture, lamentando che nelle concessioni di terre fatte nel passato molti contadini avessero rivenduto le loro quote. In realtà le invasioni di terre dell’intero biennio 1919-1920, fatta qualche isolata eccezione, nei Castelli Romani riguardarono soltanto terreni incolti o mal coltivati. Esse furono inoltre compiute simbolicamente, picchettando sommariamente o vangando approssimativamente terreni che si desiderava fossero ripartiti in quote, spesso incaricando i capi lega di avviare trattative con i proprietari per ottenere contratti collettivi di affitto o di vendita. Non di rado le invasioni di terre furono compiute da contadini con al seguito donne e bambini, con l’accompagnamento della banda musicale e una rappresentanza delle forze dell’ordine posta ai margini del corteo.
La spontaneità che caratterizzò tali iniziative non era data dalla mancanza di un ideale politico o di una lega di riferimento ma dall’assenza di una progettazione mirata ad una trasformazione su ampia scala dei rapporti tra mondo contadino e proprietà terriera. Tali lotte, come sostiene Caracciolo, nacquero spontaneamente «sulla base dell’immediato bisogno e del ricordo delle promesse del tempo di guerra». Molti contadini erano guidati da una precisa idea, ma molto spesso era il contesto a dare loro coraggio e la miseria e le sofferenze ad infondere determinazione. Molti erano mossi soprattutto dal disorientamento causato dalla guerra e dalla smobilitazione, dal desiderio di riguadagnare dignità e speranza e dalla convinzione che la conquista dell’agognato pezzo di terra da coltivare a vite avrebbe mutato radicalmente le proprie condizioni, consentendo di rimuovere esperienze inenarrabili di morte e di sofferenze. In un contesto simile ad Ariccia furono socialisti e repubblicani ad inaugurare la ripresa delle invasioni, mentre a Castel Gandolfo fu la Cassa rurale bianca a promuovere l’occupazione delle terre dei Bernesi da parte di 300 soci.
La situazione cominciò a mutare sensibilmente a partire dallo sciopero del 10 di aprile che inaugurò una seconda ondata di invasioni. Nei comizi cominciò a comparire con grande regolarità il riferimento alla rivoluzione russa di ottobre, alla dittatura del proletariato e l’inquadramento della lotta per la terra in un più ampio quadro che coinvolgeva l’Europa intera. Il Partito socialista denunciò in più occasioni anche l’alto numero di case tenute sfitte a fronte di un crescente bisogno di abitazioni. Accanto all’invasione di terre incolte o mal coltivate soprattutto ad Ariccia, Genzano, Rocca di Papa e Marino si cominciarono così a registrare varie occupazioni di appartamenti poco o per nulla abitati.
Ancor meno spontanee furono le invasioni che si verificarono a partire dall’agosto del 1919. La Federterra dal congresso di giugno aveva cominciato a promuovere l’iniziativa inviando alle leghe contadini circolari in cui si chiedeva di elencare quali terreni intendevano invadere, la loro estensione, la condizione colturale e il nome del proprietario. Anche in questo caso tuttavia i contadini non furono intenzionati ad ottenere l’esproprio dei terreni occupati e delegarono capi lega o sindaci di avviare le trattative con i proprietari per giungere ad una soluzione legale dell’iniziativa. Molte invasioni avvennero ancora all’alba, con zappe e vanghe ma anche con vessilli e fanfare, come quella che il 24 agosto portò centinaia di contadini di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio, Montecompatri, Colonna, Rocca di Papa, ad invadere le tenute di Torre Nuova, Molara, Pallavicina e Pantano di proprietà dei Rospigliosi, degli Aldobrandini e dei Borghese. Non diversamente anche ad Albano i contadini furono accompagnati dalla banda municipale e iniziarono e conclusero la giornata del tutto pacificamente, come le forze dell’ordine registrarono quasi ovunque.
Le denunce di danni a terreni coltivati o seminati furono assai poche e le indagini delle forze dell’ordine non furono di conforto per quei proprietari, affittuari o impiegati comunali che invocavano una dura repressione preannunciando persino violenze contro le donne della borghesia. In settembre poi giunse il decreto Visocchi che avrebbe dovuto evitare che lo stato di necessità e il risentimento dei contadini potesse trasformarsi in odio di classe. Con tale decreto, prendendo atto della necessità di aumentare la produttività nel settore agrario, dello stato di parziale o totale abbandono in cui versavano alcuni latifondi e della necessità di fare fronte all’impegno assunto con i combattenti in trincea per difendere il suolo patrio, il ministro dell’Agricoltura Visocchi autorizzò la concessione di terre incolte o mal coltivate alle associazioni contadine per un periodo massimo di quattro anni, prorogabile anche in via definitiva.
Nonostante le decisioni del governo il processo di ripartizione e di formazione della piccola proprietà coltivatrice nei Castelli fu travagliato. Le trattative furono spesso difficili, a volte incontrarono il netto rifiuto dei proprietari a discutere con sindaci o capi lega per affittare parte dei loro terreni a cooperative di lavoratori o agli stessi Comuni. In un clima politico reso più teso dall’impresa dannunziana di Fiume, dalle prime violenze fasciste, dalle imminenti elezioni politiche, dalla preoccupazione che il decreto Visocchi potesse favorire fiammate filobolsceviche e dall’autoritarismo del nuovo prefetto Zoccoletti, nei Castelli Romani le forze dell’ordine cominciarono ad assumere una funzione più in linea con le aspettative di proprietari e grandi affittuari.
Nel 1920 si assistette così ad una progressiva ritirata dell’iniziativa contadina. Nel 1919 le forze della sinistra avevano cominciato a dividersi. Repubblicani e popolari avevano cercato di sottrarre ai socialisti il monopolio della causa contadina. Per far questo però avevano adottato strategie che finirono con il premiare la reazione padronale rendendo più deboli le iniziative contadine. I repubblicani assunsero una posizione nettamente contraria al bolscevismo e, cercando un punto d’incontro con i socialisti riformisti, si concentrarono nel sostenere la causa dei contadini combattenti e le rivendicazione di terra soprattutto da parte dei reduci. Privilegiando le iniziative politiche alle manifestazioni di piazza, essi ribadirono il loro rifiuto della lotta di classe e l’idea di un solidarismo interclassista. I cattolici al contrario cercarono di combattere l’avanzata del socialismo promuovendo alcune invasioni di terre, come accadde ad esempio a Castel Gandolfo, e al tempo stesso denunciando come eccessive le pretese dei socialisti sul piano contrattuale. Delle leghe bianche nacquero così a Marino e Frascati con l’intento di portare i contadini su posizioni più facilmente mediabili e di minore conflittualità con i proprietari. Il risultato fu che le masse contadine, facendo riferimento a soggetti politici di diverso orientamento e con una diversa strategia, si resero più deboli e più facilmente divisibili.
La debolezza del movimento contadino castellano nel complesso fu però determinata dal concorso di più fattori. Era mutato l’atteggiamento delle forze dell’ordine. L’annuncio ricorrente di una rivoluzione, che sarebbe giunta inesorabilmente dalla Russia attraversando l’Europa, aveva sottratto alle iniziative contadine il loro carattere originario, facendo nascere sospetto, diffidenza o anche solo raffreddando il rapporto con la popolazione non contadina. L’insistenza della Federterra e del Partito socialista per la socializzazione delle terre ottenute con le invasioni contrastava con la speranza dei contadini castellani di trasformarsi in proprietari-coltivatori. Il mancato rispetto dei contratti appena siglati da parte dei proprietari, attraverso il ricorso alla manodopera forestiera, nonostante le ribellioni e alcuni incidenti causati in particolare a Frascati e Genzano da contadini locali, aveva alimentato una crisi di fiducia che precipitò con la sconfitta dell’armata rossa e l’arresto della rivoluzione alle porte di Varsavia. Le strategie conflittuali di popolari, repubblicani e socialisti avevano ingenerato confusione e smarrimento, favorendo un rassegnato ritorno alla contrattazione individuale.
Nel 1920 si assistette in tal modo ad una diminuzione delle invasioni di terra, ad una recrudescenza del fenomeno delle occupazioni delle case disabitate e a rinnovate vertenze per il miglioramento delle mercedi, per il collocamento e la durata della giornata lavorativa. Tutto però si svolse in un clima meno festoso e più sofferto rispetto al precedente anno. Tra le masse contadine, nelle leghe rosse, nelle sezioni del Partito socialista era comparsa la percezione di una reazione padronale che poteva vanificare le conquiste realizzate fino ad allora.
Nel 1921 e nel 1922, la comparsa di uno squadrismo inizialmente di importazione e poi di uno locale, soprattutto nei centri di Montecompatri e Genzano, fece ritrovare una certa unione e ristabilì un clima di solidarietà tra gli esponenti locali dei partiti tradizionali. La cultura fortemente solidaristica maturata nel corso dei decenni precedenti creò nelle popolazioni castellane una sorta di impermeabilità al fascismo. Ristrette minoranze, per lo più agiate, si riconobbero nel nuovo regime o si affiancarono ad esso nella speranza che il paese potesse riguadagnare stabilità e prestigio e che potesse ristabilire una chiara gerarchia sociale, dopo le martellanti rivendicazioni di masse contadine che sembravano voler sovvertire l’ordine costituito.
La maggior parte della popolazione castellana oscillò però tra un’accoglienza scettica, un’apparente indifferenza, un’opposizione interiore e taciuta e una palese contrapposizione. In un territorio in cui il fascismo si affermò come un estremismo di minoranza nato da una reazione fino ad allora quasi impotente e senza speranza alla dominante cultura solidaristica, in tanti rimase viva la determinazione acquisita negli ultimi decenni a perseguire il miglioramento delle condizioni di vita materiale. Mentre la propaganda del regime alimentava i miti che lo sostenevano, in quasi tutti i comuni dei Castelli Romani maturava un disagio ed un malessere che gli informatori della Polizia politica non poterono nascondere nelle loro relazioni. Si trattava di un disagio che nasceva dai soprusi e dalle violenze compiute da squadristi, miliziani, istruttori della premilitare, segretari del fascio. Si trattava però anche di un disagio che nasceva dalla constatazione del progressivo e sempre più drammatico peggioramento delle condizioni di vita. In una relazione del 1927 si riferiva ad esempio che a Genzano una casa di due camere e cucina di tipo comune per contadini era passata da un fitto mensile oscillante tra le 30 e le 50 lire del 1919-1920 ad uno compreso tra le 200 e le 250 lire del biennio 1926-1927, mentre nello stesso intervallo di riferimento i salari si erano ridotti mediamente di 12 lire al giorno per i contadini di I categoria e di 10 lire per quelli di II. Analogo valore ha la nota del gennaio del 1932 in cui un informatore della Polizia politica riferì che la retata che aveva portato all’arresto di una trentina di sovversivi di Albano era stata «determinata dal fatto di mal represso malumore per il pagamento delle imposte e tasse fiscali e di sobillazione da parte di alcuni elementi torbidi, per rifiutarne il pagamento». Molti castellani furono spinti proprio da quel disagio ad entrare attivamente nell’antifascismo ed ad agire nella clandestinità dal novembre del 1926, quando furono dichiarati fuori legge tutti i partiti d’opposizione.
Per molti lavoratori il fascismo rappresentò lo strumento che consentì il ritorno al potere dei potentati familiari che avevano amministrato i comuni e costretto alla miseria le masse lavoratrici fino all’inizio della prima guerra mondiale. L’opposizione al fascismo tornò così ad essere un’opposizione maturata nelle forme più disparate ad una nuova politica di tipo classista che mortificava il desiderio delle masse lavoratrici di emanciparsi, magari ottenendo un piccolo pezzo di terra da coltivare a vite. Dallo scontro che il 1° gennaio del 1925 a Genzano causò la morte di un fascista e di un comunista, l’antifascismo nei Castelli Romani ha continuato ad essere vigile e vitale, con momenti di flessione e di netta ripresa, con frequenti abbandoni dell’impegno politico anche da parte di persone esperte e capaci e arresti di massa che coinvolsero in alcuni casi quasi cento fascisti, ma anche con un ricambio generazionale continuo. Tra la fine del 1925 e il novembre del 1926 si cominciarono in effetti a manifestare le defezioni di alcuni propagandisti e politici di provata esperienza come Antero Antonelli di Frascati, l’avvocato Giuseppe Proli di Velletri, l’avvocato Luigi Pasquali di Montecompatri, gli ex sindaci di Albano Luigi Sabatini e Dante Malintoppi. In un clima di forte repressione che disseminò fermi e arresti per l’intero Ventennio, nella notte tra il 5 e 6 maggio del 1928 a Genzano furono compiute 150 perquisizioni domiciliari e 91 antifascisti furono arrestati. Nel successivo mese di agosto una nuova retata sparse decine di militi nella abitazioni di sovversivi di Frascati, Grottaferrata e Genzano, individuando in quest’ultimo comune il luogo in cui si stampava clandestinamente «L’Unità». Una nuova retata fu compiuta nel gennaio del 1932 con arresti tra Marino, Albano, Genzano e Velletri che secondo le cifre indicate dagli informatori della Polizia politica riguardarono tra i 168 e i 300 sovversivi o presunti tali. Altri arresti di interi gruppi furono compiuti nel 1937, con diciassette condanne del Tribunale speciale. Nonostante la spietatezza della repressione, la brutalità di alcuni importanti esponenti del fascio locale, nonostante le numerose condanne al confino e le ancor più numerose carcerazioni e diffide, nonostante il rischio di tradimenti e le difficoltà di riunirsi anche nelle più profonde ore notturne senza essere scoperti, nei Castelli Romani l’antifascismo rimase un sentimento e una pratica molto diffusa. In alcuni casi si manifestò con un portamento e una fierezza che rimandavano ad una vecchia militanza, con la mancata iscrizione al partito o con l’ostentazione del distintivo dell’Azione Cattolica, fino a pagare con il licenziamento, come accadde alla maestra Ines Pezzi di Albano. In altri casi si manifestò con la scarsa partecipazione alle cerimonie e alle parate. In altri ancora si rese palese con il mancato «scappellamento» o il mancato saluto romano al passaggio di un gagliardetto o il rifiuto di festeggiare le ricorrenze fasciste, con la consapevolezza dei conseguenti pestaggi e ritorsioni, come accadde all’ex sindaco socialista di Genzano, che morì al confino in seguito alle percosse subite per essersi recato nella propria vigna mentre si celebrava il Natale di Roma.
L’opposizione al fascismo e i conseguenti arresti proseguirono anche durante la guerra. Spesso l’insofferenza e le proteste nei confronti del regime furono dettate dalle difficoltà imposte dal fascismo e frutto della sua politica quasi ventennale. Alla vigilia della seconda guerra mondiale a Genzano una rivendita fu presa d’assalto da donne esasperate da un’ormai cronica mancanza di sapone, mentre analoghi episodi si verificavano anche ad Ariccia e ad Albano. In un clima reso difficile dalla generalizzata penuria di generi di prima necessità, dallo zucchero al carbone, nel maggio del 1939 a Montecompatri l’arrivo con oltre un mese di ritardo di soli 4 quintali di sapone sui 20 necessari costrinse le forze dell’ordine ad intervenire per impedire che la ressa davanti ai negozi di centinaia di persone si trasformasse in una colossale rissa. Nel 1940 a Velletri il comando dei carabinieri prospettò il rischio di disordini se non si fosse prontamente sopperito alla mancanza di solfato di rame per l’irrorazione delle viti. Negli stessi giorni la popolazione di Montecompatri era in agitazione per la cronica mancanza d’acqua persino nel lavatoio pubblico. Molti degli arrestati erano contadini, altri erano artigiani e operai. La maggior parte di loro era di orientamento comunista, non mancarono tuttavia repubblicani e socialisti. Nel 1941 alcuni incidenti si verificarono a Marino per il mancato rifornimento di olio. Nel mese di marzo oltre 14.000 tralci di vite furono tagliati nel comune di Genzano, secondo la Questura al culmine di un contrasto sorto tra lavoratori e datori di lavoro per la mancata corresponsione di un aumento salariale e per il ricorso a manodopera forestiera. In aprile ancora il podestà di Marino parlò di un clima di guerriglia che alcuni sobillatori stavano creando tra la popolazione per il mancato arrivo degli approvvigionamenti. Ad Albano, una riservata indirizzata al Capo della polizia riferì che «un centinaio di donne avevano protestato, in forma clamorosa, davanti alla sede del comune, per la mancanza della pasta del riso e dei grassi» e aggiunse che poco dopo circa 200 donne di Ariccia avevano fatto altrettanto per la mancanza di solfato di Rame. Altre manifestazioni di insofferenza si registrarono a Rocca di Papa per il ritiro di tessere alimentari e per la speculazione di alcuni commercianti con la protezione dell’annona. Nel mese di settembre la Questura riferì che a Marino «circa 150 tra donne e ragazzi riunitisi nell’atrio del palazzo comunale, reclamarono a gran voce la distribuzione dei generi di minestra del mese scorso». La protesta dunque era pressoché continua ed era alimentata non da pregiudizi o da accecamenti ideologici ma dalla sofferenza, dagli stenti e dal bisogno di speranza.
Attraverso quelle esperienze l’antifascismo castellano maturò un ulteriore rafforzamento delle proprie aspirazioni democratiche. Il fascismo stava drammaticamente sottolineando che il benessere materiale cui aspiravano le masse contadine non poteva essere disgiunto dalla realizzazione di un sistema democratico, l’antifascismo a molti indicò la strada che idealmente avrebbero dovuto percorrere per un’ulteriore crescita civile e ideale. Essere antifascista voleva dire essere contro una politica fondata arrogantemente su privilegi di classe o gruppi sociali, essere contro la violenza eretta a sistema e la guerra come strumento della diplomazia ed essere contro la dittatura, contro l’antidemocrazia.
Questa maturazione funse da collante dopo l’8 settembre, quando tra le colline dei Castelli Romani si accese un’animata guerra di resistenza contro il fascismo cadente e il tedesco occupante. Fianco a fianco combatterono uomini di diverso orientamento ideale: socialisti, comunisti, repubblicani, cattolici ma anche monarchici e dannunziani. Il loro obiettivo fu di contribuire alla nascita e alla costruzione di uno Stato che forte dell’esperienza fascista avrebbe dovuto realizzare condizioni di vita più giuste e venire incontro alle necessità delle masse contadine.
Già nel 1944 ripresero così le invasioni di terre del latifondo, incolte o mal coltivate, si riaccesero le battaglie per i contratti bracciantili e dei lavoratori edili, come a riprendere un discorso interrotto prima dalla guerra e poi dall’avvento del fascismo. La prima invasione fu del marzo del 1944 e fu compiuta dai contadini di Genzano sulle terre dell’ex podestà Armenise. Nel successivo mese di ottobre giunse poi un decreto governativo che, analogamente al decreto Visocchi del 1919, previde la cessione a cooperative di lavoro delle terre incolte o malcoltivate. Le invasioni si ripeterono così numerose con una forte impronta legalitaria che veniva dal medesimo carattere delle invasioni di inizio secolo, da una richiesta di giustizia che si era andata definendo dal XIX secolo e che anche nei momenti più difficili solo sporadicamente si confuse con un bisogno di rivalsa o di vendetta.
La repressione però non tardò a manifestarsi di nuovo. Nel pieno di una nuova ondata d’invasioni, nel 1945 si tornò a parlare di occupazione di terreni regolarmente coltivati e di partiti che sobillavano i contadini spingendoli ad agire al di là del loro reale fabbisogno, nonostante le stesse forze dell’ordine riconoscessero che si trattava di occupazioni simboliche, che rinviavano come quelle di inizio secolo ad una soluzione contrattuale della controversia. La preoccupazione che le iniziative contadine potessero trasformarsi in un fenomeno eversivo e divenire strumento rivoluzionario dei partiti della sinistra era alimentata dal clima determinato dalla guerra fredda e dalla conseguente manovra di estromissione del partito comunista dal governo. Nel settembre del 1947 nel Lazio e nei Castelli Romani vi fu una nuova ondata di occupazioni che ricordava quella dell’agosto del 1919. Come quella era organizzata dalla Federterra che, a conclusione di trattative fallimentari per il miglioramento dei salari, la riduzione della disoccupazione e la terra, programmò l’invasione di terre incolte di proprietà dell’aristocrazia romana. Come la precedente iniziativa anche questa per molti segnò il tramonto di un sogno e la negazione di un bisogno più che un fallimento sul piano ideologico o politico. La rottura dell’alleanza antifascista nel 1947 determinò anche la rottura sindacale e il conseguente indebolimento del movimento contadino. Nei Castelli Romani si avvertì che era stata sconfitta l’idea che la terra avesse un valore sociale e che in quanto tale fosse una questione di giustizia assegnare ai contadini poveri i terreni incolti o malcoltivati. Tale consapevolezza, più che mutare, ha contribuito a rafforzare l’orientamento di fondo delle popolazioni castellane, che per molti decenni della storia repubblicana hanno continuato ad esprimere largamente un orientamento democratico e progressista, a vivere orgogliosamente il ricordo dell’antifascismo e individuare nella Resistenza una sorta di secondo Risorgimento ma, al tempo stesso, anche una rivoluzione incompiuta, soprattutto per quel che riguardava la terra e l’emancipazione delle masse contadine.
Ugo Mancini, studioso del movimento contadino e del fascismo, ha collaborato con il «Centro interdipartimentale per lo studio delle trasformazioni del territorio» dell’Università di Roma «Tor Vergata» e collabora attualmente con il «Museo Storico della Liberazione» di Roma al Dizionario Storico Biografico del Lazio.
Ha pubblicato Lotte contadine e avvento del fascismo nei Castelli Romani (Roma 2002), 1939-1940. La vigilia della seconda guerra mondiale e la crisi del fascismo a Roma e nei Castelli Romani (Roma 2004), La lotta politica nei Castelli Romani tra Ottocento e Novecento (in «Giornale di Storia contemporanea», giugno 2006), A metà del guado. Il fascismo dal 1925 al 1929 (in stampa). È autore di un manuale di storia per i licei.